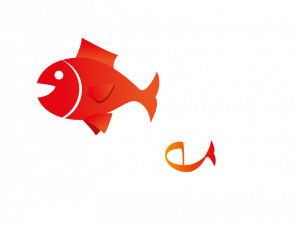Sanihelp.it – All’inizio degli anni Settanta in un villaggio turco della Cappadocia gli abitanti morivano per una malattia polmonare che si supponeva essere tubercolosi, allora piuttosto diffusa. Peccato che i farmaci antitubercolari non funzionassero affatto e anni dopo si scoprì il perché: non si trattava di tubercolosi, bensì di una forma tumorale al polmone, il mesotelioma pleurico, di solito provocata dall’amianto. Ma nella regione non c’era amianto. Approfondite ricerche chiarirono in seguito che il mesotelioma era provocato dall’erionite, appartenente al gruppo delle zeoliti, minerali presenti principalmente in rocce vulcaniche e di ampio impiego in vari settori, dall’edilizia all’agricoltura. Le zeoliti in generale non sono dannose per l’uomo, tranne appunto l’erionite che, se inalata, è centinaia di volte più tossica dell’amianto.
Un recente studio congiunto tra Sapienza Università di Roma, Università di Genova ed ENEA (Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie), ha indagato i meccanismi alla base della tossicità dell’erionite finora ancora poco chiari. I ricercatori hanno scoperto che le fibre di erionite, se inalate, vengono inglobate dai macrofagi, le cellule del sistema immunitario con il compito di eliminare le sostanze estranee tossiche per l’organismo. L’erionite altera il pH intracellulare provocando il malfunzionamento dei lisosomi, organelli che intervengono nella degradazione delle macromolecole, dei microrganismi e dei frammenti cellulari fagocitati e inoltre degradano organuli invecchiati. Se i lisosomi non funzionano, si va incontro a morte delle cellule e infiammazione cronica, che favoriscono l’insorgenza di tumori.
«L’erionite – spiega Anna Moliterni, ricercatrice nel gruppo di ricerca guidato da Cinzia Giannini, direttrice dell’Istituto di cristallografia (Cnr-Ic) – è classificata come cancerogena dall’International Agency for Research on Cancer (IARC). Anche se non fa parte della famiglia dei minerali dell’amianto, non è meno insidiosa per la salute, infatti, non solo è stata accertata la relazione causa-effetto tra l’esposizione all’erionite e l’insorgenza di mesotelioma pleurico maligno (MM), ma il potere cancerogeno dell’erionite si è rivelato anche più elevato di quello dell’amianto». Ne è una dimostrazione quanto è avvenuto in Turchia, in tre paesini dell’Anatolia centrale: «Per costruire abitazioni ed edifici», aggiunge Moliterni, «i loro abitanti hanno utilizzato, come spesso avviene, la roccia del luogo, un tufo friabile contenente erionite, ignari del fatto che quella che consideravano una risorsa naturale con il passare del tempo si sarebbe rivelata un killer silenzioso e spietato, responsabile di più del 50% delle morti della zona, causate dall'MM. L’erionite si trova in natura sotto forma di fasci di fibre sottilissime, il cui aspetto ricorda un batuffolo di lana (erion in greco significa lana) e, molto più raramente, come singole fibre aghiformi. È frequente il suo concrescimento con altri minerali (ad es. con l’offretite). Per queste ragioni fino allo scorso anno è stata studiata esclusivamente mediante diffrazione da polveri, costituite da moltissime fibre».