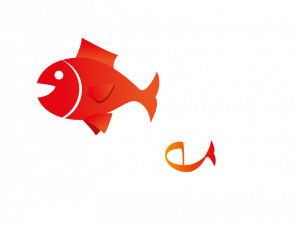Sanihelp.it – Lo scorso luglio, al termine delle Giornate dell’etica organizzate dall’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) in Sicilia, è stata redatta da un gruppo multidisciplinare la Carta di Ragusa sull’Etica in Oncologia. Il documento punta a migliorare l’integrazione dell’etica nell’organizzazione del sistema sanitario e nei comportamenti dei singoli professionisti. Quattro i principi su cui la Carta si basa: condivisione delle scelte terapeutiche, empatia nella relazione medico-paziente, equità di accesso alle cure innovative e valorizzazione della ricerca clinica. La carta sarà a disposizione dei cittadini presso gli ospedali.
Il professor Carmine Pinto, presidente nazionale AIOM, ha commentato: «È nostro preciso dovere occuparci di questi aspetti. Siamo molti orgogliosi di questo documento che vuole diventare anche una sorta di Carta dei Doveri per tutti gli specialisti coinvolti nella cura del cancro. In particolare, ci siamo soffermati sul delicato rapporto tra medici, pazienti e i loro familiari».
Nel primo punto del documento infatti si legge: «L’oncologo deve sempre più tenere in considerazione le esigenze della persona assistita e dei familiari. Senza dimenticare di prestare molta attenzione alle possibili differenze culturali, dato che curiamo anche molte persone di origine straniera». E ancora: «Sono da evitare, da parte di tutto il personale sanitario, atteggiamenti ostili verso la sofferenza del malato e dei caregivers. È fondamentale stabilire invece una proficua alleanza emotiva con loro».
A rivestire particolare importanza è anche la comunicazione con il paziente: «Il medico oncologo ed il team curante devono garantire il coinvolgimento della persona assistita nel processo decisionale fornendo una informazione adattata ai bisogni individuali e attuando una comunicazione efficace con pazienti e familiari». Al tempo stesso il personale sanitario deve «fornire al malato gli strumenti conoscitivi del suo stato di salute, al fine di garantirgli la libertà di scelta, non influenzabile da esterni. Il medico e l’assistito devono esercitare il loro ruolo legittimo nella decisione terapeutica, dichiarando le loro preferenze e il razionale della loro scelta, nel tentativo di costruire un consenso sul trattamento più appropriato da applicare».
La Carta di Ragusa poi obbliga gli oncologi a «mantenere sempre un approccio e un rigore scientifico metodologico non solo nella scelta delle terapie ma anche nella relazione medico-paziente, in base alla medicina basata sull’incidenza». «Alla persona assistita deve inoltre essere garantita la continuità nel rapporto con i propri sanitari in tutte le fasi della malattia e il medico deve assicurare la condivisione partecipata delle scelte di fine vita, in particolare della desistenza terapeutica, affinché la rinuncia ad ulteriori trattamenti non sia avvertita come abbandono, ma come parte dell’assistenza. Il ruolo del curante non è tanto quello di rispettare la dignità del malato, ma di chiedersi quale relazione serva per dare dignità al paziente».
Le nuove cure hanno aumentato sensibilmente la sopravvivenza. Molti farmaci però hanno costi importanti che influiscono pesantemente sui bilanci degli ospedali e dei conti pubblici. Esiste dunque un problema di equità e accessibilità alle cure che devono sempre essere garantite a tutte le persone colpite dal cancro. «Non deve essere il clinico – prosegue la Carta – a far prevalere considerazioni economiche sulla valutazione rischio-benefici delle possibili scelte terapeutiche. È invece importante che queste considerazioni siano prese ad un livello decisionale più alto e comunque il più lontano possibile dal singolo rapporto medico-paziente. Il costo dei trattamenti infine deve essere proporzionato alla loro reale efficacia e sicurezza. Devono essere esplorate nuove strategie di rimborsabilità con gli enti regolatori».
Gli ultimi tre articoli della Carta di Ragusa sono dedicato alla ricerca clinica indipendente che «va sostenuta e incoraggiata, in quanto di interesse pubblico e non a fini di lucro, finalizzata a testare strategie terapeutiche per il miglioramento della pratica clinica. È auspicabile un’organizzazione dei Comitati Etici che preveda Comitati Etici coordinatori (regionali/macroregionali) per l’espressione del Parere Unico, e, nell’ospedale dove si svolge la sperimentazione, un Clinical Trial Office, per esprimere un giudizio di fattibilità locale e supportare gli sperimentatori. La partecipazione ad attività di ricerca clinica rappresenta un valore per i pazienti, per i professionisti sanitari e per le strutture partecipanti, e come tale deve essere adeguatamente riconosciuta ed apprezzata dalle Direzioni, che devono creare le condizioni e fornire le risorse necessarie».