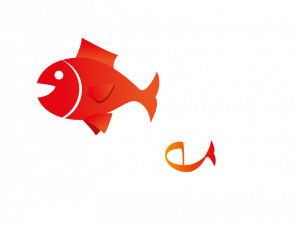Sanihelp.it – I papilloma virus umani (HPV, dall’inglese Human Papilloma Virus) sono virus a Dna la cui trasmissione avviene soprattutto per via sessuale e che si replicano nelle cellule dell’epidermide.
Ne esistono oltre 120 varianti, circa 40 tipi interessano la cervice uterina, la vagina, la vulva, l’ano, il pene e l’orofaringe; per alcuni di questi si parla di HPV ad alto rischio perché la loro presenza è correlata all’insorgenza di vari tipi di tumori e infezioni. Per contrastare i papilloma virus dunque occorre attuare strategie preventive, aderire ai programmi di screening e ai piani vaccinali.
I virus HPV maggiormente responsabili delle patologie HPV correlate maligne e benigne sono quattro: 6, 11, 16 e 18. I tipi 6 e 11 (detti a basso rischio), sono responsabili del 90% dei condilomi: infezioni contagiose e molto dolorose, che interessano gli organi genitali e altre mucose (come nel caso della papillomatosi respiratoria ricorrente che interessa il cavo orale). I tipi 16 e 18, invece, sono responsabili di circa il 70% di tutti i tumori del collo dell’utero, ma possono causare anche il cancro a vulva, vagina, ano, pene e i tumori del distretto testa-collo.
L’infezione da HPV si trasmette soprattutto attraverso rapporti sessuali (vaginali o anali) non protetti con partner portatori; è bene sottolineare come il rischio di contrarre il virus cresca con l’aumentare del numero dei partner e che sebbene sia fondamentale utilizzarlo, il profilattico non protegga completamente dalla possibilità di infezione. Più raramente, la trasmissione può avvenire mediante rapporti sessuali orali o manuali.
Secondo le stime, oltre il 75% delle donne sessualmente attive va incontro a infezione da virus HPV nel corso della vita, con un picco nelle giovani fino a 25 anni di età. La maggior parte delle infezioni da HPV è transitoria, perché il virus viene eliminato dal sistema immunitario prima di sviluppare un effetto patogeno. In caso di infezione persistente, il tempo che intercorre tra l’infezione e l’insorgere di lesioni precancerose è di circa cinque anni, mentre la latenza per lo sviluppo di un tumore, come quello alla cervice, può essere anche di 20-30 anni.
L’HPV può causare diversi tipi di cancro e nella donna è la causa principale del tumore al collo dell’utero. Questo tipo di cancro non può insorgere senza la presenza e l’azione trasformante di alcune forme di virus ad alto rischio oncologico come i tipi 16 e 18.
Pap-test, HPV DNA Test e colposcopia sono strumenti di diagnosti precoce che consentono di riconoscere le lesioni precancerose e permettono di poterle trattare prima che la malattia si sviluppi. Questo è il motivo per cui mentre l’infezione da HPV è estremamente diffusa in tutto mondo, il cancro della cervice può considerarsi una malattia a diffusione limitata. Rispetto ad altre neoplasie, questa forma di cancro ha il vantaggio di essere prevenibile e ben curabile se rilevata precocemente.
Il Pap-test e l’HPV Dna test sono esami delle cellule che desquamano dal collo dell’utero finalizzati alla ricerca di cellule anomale (Pap-test) o del Dna dell’HPV (HPV DNA test), mentre la colposcopia è un esame che permette la visione ingrandita del collo dell’utero con individuazione dell’area più sospetta dove praticare una biopsia, ovvero l’asportazione di un frammento di collo dell’utero da analizzare con l’esame istologico.
Dopo decenni di ricerca, sono stati messi a punto tre vaccini contro i Papillomavirus altamente efficaci, ben tollerabili e sicuri: un vaccino bivalente, efficace verso i tipi di Papillomavirus 16 e 18; un vaccino quadrivalente, utile verso i tipi di Papillomavirus 6, 11, 16 e 18 e un vaccino nonavalente per proteggersi dai ceppi di Papillomavirus 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58.