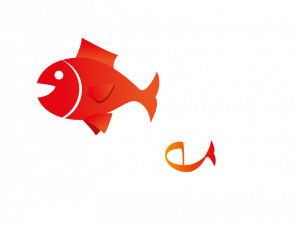Sanihelp.it – La formazione
Siamo in un mondo in rapida evoluzione e anche in ambito medico le conoscenze che si consideravano acquisite devono adattarsi al ritmo incessante della trasformazione moderna.
Ecco quindi che la già lunga e difficile preparazione accademica del medico deve necessariamente evolversi: i futuri medici devono avere una forte preparazione per affrontare un futuro in continuo sviluppo e sempre più legato a tecniche innovative.
Per capire come è cambiato l’iter formativo del medico Sanihelp.it ha intervistato il professor Giuseppe Scotti, preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia e professore straordinario di Neuroradiologia dell’Università Vita-Salute San Raffaele, che ci ha illustrato il percorso scolastico e le attuali prospettive di lavoro di questa figura professionale.
«Oggi la formazione del medico avviene durante sei anni di studio divisi in semestri (il cosiddetto Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico).
Per l’attività in ospedale è richiesta una specializzazione di quattro-cinque anni. Esistono poi possibilità di ulteriori formazioni professionalizzanti tramite master. E per il lavoro di ricerca si può scegliere tra numerosi dottorati».
Cosa è cambiato per il Corso di Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia (ora Laurea Magistrale) con la riforma del 1999?
«Sono previsti un contatto più precoce con il paziente (già al secondo anno), l’abolizione della suddivisione in triennio biologico e triennio clinico e l’integrazione degli insegnamenti in compresenza di più docenti.
Inoltre è stata sviluppata una attività tutoriale con uno stretto rapporto con docenti tutori sia nei laboratori che al letto dei malati».
Il professore prosegue spiegando che, pur nell’autonomia dei programmi delle diverse facoltà, esiste un nucleo di insegnamenti comuni che costituiscono il core curriculum: una serie di obiettivi formativi che devono essere acquisiti da ogni medico moderno.
Vi sono poi corsi elettivi scelti in funzione di propri interessi o vocazioni.
«Sono previsti tirocini pratici presso gli studi di medicina generale per conoscere l’organizzazione e la pratica medica del territorio.
Un sesto dell’attività viene svolto nei reparti come attività professionalizzanti.
La conoscenza dell’inglese è indispensabile, sia per consultare la letteratura scientifica sia per partecipare ai seminari.
Molto interessante il corso di Medicina e Società, nel quale vengono affrontati problemi di bioetica e relazione con il paziente: la nascita, la malattia, la morteà¢àÂ঻
E dopo la laurea? «Dopo un tirocinio valutativo di tre mesi è necessario passare un test nazionale di abilitazione per esercitare la professione di medico chirurgo ed eventualmente iscriversi alle Scuole di Specializzazione».
La professione
L’articolo 3 del Codice Deontologico della FNOMCeO (Federazione Nazionale Ordini Medici Chirurghi e Odontoiatri) afferma che «dovere del medico è la tutela della vita, della salute fisica e psichica dell’Uomo nel rispetto della libertà e della dignità della persona umana, senza discriminazioni di età, di sesso, di razza, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia, in tempo di pace come in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera.
La salute è intesa nell’accezione biologica più ampia del termine come condizione di benessere fisico e psichico della persona».
L’esercizio medico, attraverso una tradizione millenaria, costituisce il primo e più immediato mezzo di difesa della salute come diritto dell’individuo e interesse della collettività.
L’etimologia latina lo conferma: il sostantivo medico deriva da medeor, che significa curare: il medico è colui che cura, o meglio, che si prende cura. La medicina è quindi l’arte di prendersi cura delle persone che avvertono uno stato di malessere o che presentano sintomi di una malattia.
Ma quali sono nel dettaglio le competenze e i doveri di un medico? Leggiamo ancora dal Codice Deontologico che il medico deve:
- attenersi alle conoscenze scientifiche e ispirarsi ai valori etici fondamentali, assumendo come principio il rispetto della vita, della salute fisica e psichica, della libertà e della dignità della persona
- non soggiacere a imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura
- garantire impegno e competenza professionale, non assumendo obblighi che non sia in condizione di soddisfare
- affrontare i problemi diagnostici con il massimo scrupolo, dedicandovi il tempo necessario per un approfondito colloquio e per un adeguato esame obiettivo
- nel rilasciare le prescrizioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, fornire, in termini comprensibili e documentati, tutte le idonee informazioni e verificarne la corretta esecuzione
- assicurare al cittadino la continuità delle cure
- garantire il proprio costante aggiornamento, per adeguare le sue conoscenze e competenze al progresso clinico scientifico.
A proposito di quest’ultimo punto «si usa definire la professione di medico un lifelong learning process, cioè un processo di apprendimento continuo che dura tutta la vita», afferma il professor Scotti.
Per questo motivo gli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri sono tenuti a tenere periodicamente ai propri iscritti corsi di aggiornamento e di approfondimento.
Le prospettive per il futuro
Secondo l’articolo 4 del Codice Deontologico «l’esercizio della medicina è fondato sulla libertà e sull’indipendenza della professione».
La difesa della libertà e dell’indipendenza del medico ha assunto ancora più rilevanza considerando che, ormai da tempo, l’esercizio professionale può essere svolto anche in regime di dipendenza (art. 47 legge 833/78) o di convenzionamento.
La Laurea in Medicina e Chirurgia offre molti sbocchi professionali, ma i più importanti sono tre:
- medico di medicina generale
- medico specialista, ambulatoriale o ospedaliero
- ricercatore, non solo clinico, ma anche e soprattutto nelle scienze mediche di base.
Le opportunità di specializzazione sono al giorno d’oggi moltissime, in considerazione dell’enorme sviluppo delle conoscenze e delle tecnologie.
Ma com’è la situazione attuale dei medici italiani e dell’organizzazione sanitaria nazionale?
Risponde il professor Scotti: «L’esercizio della professione medica e l’organizzazione della Sanità in Italia hanno risentito nei decenni passati di alcuni ritardi rispetto al resto del mondo occidentale.
In particolare l’Italia ha sofferto di una pletora di medici, dovuta alla liberalizzazione indiscriminata degli accessi alle università negli anni Settanta e Ottanta.
Questo fenomeno si va progressivamente riducendo, grazie all’introduzione del numero chiuso e ai pensionamenti, e non dovrebbe interferire con la professione dei giovani che si iscrivono oggi all’università.
L’organizzazione sanitaria è in progressivo miglioramento e l’Italia comincia a vantare strutture di assistenza, di ricerca e di formazione medica al passo con i migliori modelli al mondo.
L’Università Vita-Salute San Raffaele e l’Istituto Scientifico Universitario San Raffaele si collocano in questo ambito: la stretta vicinanza delle strutture e dei laboratori di ricerca con i reparti dell’Ospedale consente un costante rapporto e una facilità e rapidità di trasferimento in ambito clinico delle scoperte scientifiche effettuate nei laboratori».
Gli aspetti umani
«Il rapporto continuativo con la sofferenza richiede una particolare sensibilità da parte del medico, nonché un’adeguata capacità di relazione», spiega il professor Scotti.
«Un buon medico non è solo un buon scienziato, un fine diagnosta o un abile utilizzatore di moderne tecnologie. È necessario che il medico senta la responsabilità dell’influenza che il proprio atteggiamento ha sulla totalità della persona che a lui si rivolge perché malata.
L’approccio cosiddetto olistico al paziente, e non settoriale alla malattia, richiede che il medico sia anche un umanista e che sappia dare il giusto peso agli aspetti sociali, antropologici e filosofici dell’esistenza.
Una dote fondamentale, che si deve possedere ma anche coltivare, è la capacità di comprendere il paziente e i suoi problemi, di porsi in un atteggiamento di condivisione, di empatia della sofferenza.
Il rapporto di vicinanza con la facoltà di Filosofia offre alla Facoltà di Medicina del San Raffaele una opportunità di scambio e di condivisione proficua e stimolante di questo tipo di problemi».
L’importanza di instaurare una cooperazione tra medico e paziente ha portato alla diffusione crescente dei corsi di counselling: si tratta di uno strumento prezioso per un medico, che consente di affinare e migliorare le sue capacità comunicative, contribuendo a evitare, per quanto è possibile, malintesi, incomprensioni, conflitti con il paziente.
Il counselling costruisce un percorso di aiuto e accompagnamento psicologico del paziente, permettendo di mantenere una buona relazione terapeutica anche in situazioni difficili come il rifiuto da parte di quest’ultimo di una determinata diagnosi o di alcune cure.