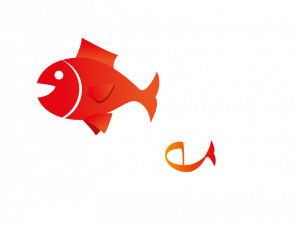Sclerosi Sistemica
La malattia è anche conosciuta come:
sclerodermia, sclerosi sistemica progressiva, ssp
Dalla Sclerosi Sistemica si può guarire? Forse ancora no, però possiamo dire che con una diagnosi precoce e le cure giuste la malattia si può “spegnere”. Questo soprattutto grazie ai progressi della terapia farmacologica…
Categoria: Malattie immunologiche
Sigla: SSc
Che cos’è – Sclerosi Sistemica
Cos’è la Sclerosi Sistemica?
La sclerosi sistemica (SSc) è una patologia cronica che rientra nel gruppo delle malattie reumatiche autoimmuni.
Uno degli aspetti salienti della SSc è la fibrosi della cute e degli organi interni, a cui si associano alterazioni dei piccoli vasi arteriosi (arteriole e capillari).
Un altro segno clinico costante è il fenomeno di Raynaud, cioè il cambiamento del colore della pelle delle mani che, in risposta al freddo o allo stress emotivo, diventa prima pallida (bianca), poi cianotica (blu), per riprendere infine il normale colore, spesso particolarmente accentuato (rosso). Il problema, dovuto a spasmo delle arteriole digitali e conseguente alla diminuita perfusione sanguigna (ischemia) distrettuale, si accompagna generalmente a diminuzione della temperatura cutanea, dolore e alterata sensibilità. Nei casi gravi si possono avere lesioni trofiche, ulcere e gangrena. Il fenomeno di Raynaud è parte integrante del quadro clinico, tanto che la sua assenza deve far porre in dubbio la diagnosi stessa di SSc.
Oltre alla fibrosi e alle alterazioni vascolari, i pazienti affetti da SSc hanno anche un’alterata reattività immunitaria, rivelata dalla presenza nel siero di anticorpi caratteristici, diretti contro alcuni costituenti del nucleo cellulare.
Chi soffre di SSc? Come tutte le malattie caratterizzate da un’iperattività del sistema immunitario, come l’artrite reumatoide e il lupus eritematoso sistemico, la SSc predilige il sesso femminile: in tutto il mondo le donne colpite da SSc superano di gran lunga i maschi. In Italia il rapporto donne/uomini è circa 8- 9 a 1.
Ma se è vero che la sclerodermia è una malattia tutta al femminile, bisogna però dire che nei maschi ha un andamento più rapido e grave, con un’aspettativa di vita minore. Non si conoscono le cause di questa differenza. La maggior parte degli uomini colpiti da Sclerosi Sistemica sviluppa molto precocemente impotenza.
La Sclerosi Sistemica può manifestarsi a tutte le età, eccezionalmente anche nell’età infantile. Il picco di insorgenza è tra i 40 e i 50 anni. La forma più grave insorge spesso più precocemente e colpisce i giovani tra i 20 e i 25 anni.
Cosa succede quando la malattia colpisce una donna in gravidanza? Le statistiche indicano una maggiore incidenza di ritardo nella crescita fetale e di bambini sottopeso alla nascita, ma le segnalazioni non sono numerose.
Si può dire, in linea generale, che la gravidanza non peggiora il decorso clinico della malattia, può ovviamente aggravare alcune situazioni, quali per esempio il reflusso gastroesofageo, disturbo frequente anche nelle gravidanze normali.
La gravidanza andrebbe evitata o per lo meno seguita con particolare attenzione quando la donna presenti uno scompenso cardiocircolatorio o condizioni cliniche gravi.
6835
![]()
Quale sclerodermia?
Anche ai non addetti ai lavori il termine Sclerodermia, letteralmente pelle dura, dà un’idea abbastanza precisa di quella che è la caratteristica più evidente della malattia: l’indurimento e l’ispessimento della cute in zone più o meno ampie della superficie corporea. Ecco perché, fino a qualche anno fa, la Sclerodermia era considerata dai pazienti, ma anche da molti medici, una malattia della pelle, tanto che il principale punto di riferimento era il dermatologo.
Esistono effettivamente forme di Sclerodermia che colpiscono solo la pelle e che per questo vengono indicate come Sclerodermia localizzata, anche se in alcuni casi il coinvolgimento cutaneo è molto esteso.
Le forme di Sclerodermia localizzata, che comprendono tra le altre la Sclerodermia in banda, la Morfea e la Morfea generalizzata, si accompagnano così raramente a interessamento viscerale da essere considerate malattie distinte dalla Sclerosi Sistemica (SSc). In questa vengono sempre colpiti, oltre alla cute, i piccoli vasi arteriosi e gli organi interni: soprattutto l’apparato gastrointestinale, i polmoni, i reni e il cuore. Sono queste localizzazioni, assolutamente silenti per mesi o anni, e quindi facilmente misconosciute, che fanno della Sclerosi Sistemica, ancora oggi nota più con il suo vecchio nome Sclerodermia, una malattia grave, altamente invalidante e a esito fatale.
Ecco una classificazione schematica delle Sclerodermie.
1. Sclerodermia localizzata
-Morfea
-Morfea generalizzata
-Sclerodermia Lineare o Banda
2. Sclerosi Sistemica
-Sclerodermia preclinica (eady scleroderma)
-Sclerosi sistemica diffusa
-Sclerosi sistemica limitata e Sindrome CREST
-Sclerosi sistemica senza coinvolgimento cutaneo (sine-scleroderma)
3. Sclerodermia in corso di altre malattie del connettivo
4. Sindromi Simil-Sclerodermiche -Cause legate all’attività lavorativa (tossici ambientali, vibrazioni)
-Farmaci (metisergide, beta bloccanti)
-Malattie metaboliche
-GVH (malattia del trapianto contro l’ospite) cronica.
6836
![]()
Cause della SSc: nessuna certezza, solo ipotesi
Le cause della Sclerosi Sistemica non sono note. In alcuni casi è però possibile individuare un legame tra l’insorgenza della malattia e l’assunzione di particolari farmaci o l’esposizione a tossici ambientali quali il cloruro di vinile e il tricloretilene. La malattia è anche più frequente nei soggetti che per la loro attività lavorativa sono sottoposti a vibrazioni prolungate (personale degli aeroporti, addetti ai martelli pneumatici).
In realtà, tali cause sono riconoscibili in un numero così piccolo di soggetti da far concludere che, nella maggior parte dei casi, non esiste alcun fattore causale apparente.
Da quanto si conosce sui meccanismi coinvolti nello scatenamento di altre malattie a patogenesi immunitaria, è possibile pensare che tra gli agenti scatenanti ci siano anche i virus. Alcune recenti osservazioni puntano il dito in particolare sui virus erpetici, soprattutto il Citomegalovirus, e il virus dell’epatite C.
In realtà la diffusione di questi microrganismi nella popolazione generale è elevatissima, mentre la Sclerosi Sistemica è piuttosto rara: è quindi evidente che la costituzione genetica dell’ospite è molto importante perché la malattia si possa sviluppare.
Questo non significa che la SSc sia una malattia ereditaria. La familiarità per Sclerodermia è sicuramente rara, anche se esistono, anche in Italia, dei nuclei familiari con più soggetti colpiti dalla malattia. É invece più facile, ma comunque non frequente, trovare tra i familiari dei malati sclerodermici soggetti con altre malattie autoimmuni, in particolare con artrite reumatoide. Esiste in effetti una predisposizione individuale ad ammalare di Sclerodermia che dipende dal substrato genetico dell’individuo.
Questo risulta particolarmente evidente nell’area mediterranea, dove la malattia sembra prediligere i soggetti che hanno un particolare antigene di istocompatibilità, l’antigene HLADR11. In Italia questo antigene è presente nel 70% circa dei pazienti con SSc, ma solo nel 40% della popolazione normale.
Esistono poi molti altri geni che possono aumentare la suscettibilità alla sclerodermia: quelli che regolano la produzione o la degradazione del collagene (agiscono cioè sulla fibrosi), quelli che influenzano l’attività del sistema immunitario o dei fibroblasti, o che agiscono sul danno delle cellule endoteliali.
6837
![]()
Sclerosi Sistemica: malattia rara, ma non rarissima
La Sclerosi Sistemica (SSc) è diffusa in tutte le aree geografiche e deve essere considerata una malattia rara, ma non rarissima. Per ogni milione di persone vi sono 10-15 nuovi casi all’anno. Questi dati si riferiscono a vecchie statistiche.
Studi epidemiologici più recenti, che provengono soprattutto dagli Stati Uniti, suggeriscono che l’incidenza della malattia è maggiore di quanto fino a oggi sospettato e che tende ad aumentare. È però probabile che questo aumento sia anche dovuto a un affinamento dei mezzi di diagnosi a nostra disposizione, mezzi che sono oggi in grado di individuare precocemente, già nella fase dei primi sintomi, e in particolare tra i pazienti con fenomeno di Raynaud, quelli che svilupperanno la SSc.
Sulla base delle cifre che abbiamo appena citato, si può calcolare che in Italia ogni anno si ammalano di Sclerosi Sistemica circa 1000 persone. Considerando la durata di vita degli ammalati, si può facilmente stabilire che, in Italia, le persone colpite da Sclerosi Sistemica potrebbero essere non meno di 30.000 e forse, 50.000 unità.
Nonostante la sua diffusione, nel nostro Paese la malattia è però scarsamente conosciuta, spesso non diagnosticata o diagnosticata tardivamente, anche in presenza di manifestazioni cliniche conclamate.
6838
Sintomi – Sclerosi Sistemica
Dalla cute al cuore, ecco i sintomi della Sclerosi Sistemica
In genere il primo segnale di allarme della Sclerosi Sistemica è rappresentato dall’insorgenza del fenomeno di Raynaud, che in alcuni soggetti può precedere anche di anni i primi segni di sclerosi cutanea.
Nella maggior parte dei casi l’esordio della malattia è estremamente insidioso, la sclerosi cutanea è limitata alle dita delle mani o alle porzioni distali degli arti, l’interessamento viscerale si sviluppa lentamente nel giro di anni.
Nel 10-15% dei casi invece l’esordio è improvviso, l’interessamento cutaneo è diffuso e rapidamente progressivo. In questi pazienti l’interessamento viscerale, che rappresenta il principale fattore di morbilità e di mortalità, si instaura precocemente ed evolve rapidamente verso il deficit funzionale.
Nella fase iniziale della malattia le lesioni cutanee sono generalmente localizzate alle mani, che appaiono gonfie e dolenti. Con il progredire della malattia, nelle zone interessate la cute perde elasticità, diventa indurita, ispessita, rigida, translucida. Vi è l’atrofia dei polpastrelli con perdita delle impronte digitali, irrigidimento della bocca con formazione di numerose striature poste a raggiera intorno alle labbra, che perdono la normale conformazione.
Soprattutto al volto, appaiono numerosissime neoformazioni vascolari, come capillari dilatati. Si possono formare ammassi di calcio nei tessuti molli, causa di infiammazione e ulcere molto dolorose. In alcuni casi i depositi di calcio possono essere massivi e, quando si verificano in corrispondenza dei capi articolari, possono portare a un blocco articolare con impotenza funzionale.
L’interessamento dell’esofago è presente nel 90% circa dei pazienti. I sintomi più precoci sono le eruttazioni acide e i bruciori retrosternali. L’infiammazione della mucosa esofagea può dare vere e proprie ulcere e cicatrici che possono provocare un restringimento dell’esofago e ostacolarne così lo svuotamento. A lungo andare tutto questo provoca delle alterazioni molto evidenti radiologicamente: esofago dilatato, sfiancato, pieno di materiale alimentare e con la mucosa ingrossata e ulcerata per l’infiammazione. Gonfiore addominale, stipsi e vere e proprie coliche da subocclusione, nonché episodi ricorrenti di diarrea, sono i disturbi avvertiti quando la fibrosi colpisce l’intestino.
Fiato corto, soprattutto in occasione di sforzi fisici, maggiore affaticamento muscolare e tosse stizzosa sono i sintomi che segnalano che il polmone non è più in grado di svolgere adeguatamente il suo compito, quello di ossigenare il sangue prima che torni nel circolo sistemico.
In alcuni individui affetti da SSc l’alterazione principale interessa i vasi con sviluppo di ipertensione polmonare, che ha sul cuore effetti devastanti provocando uno scompenso cardiaco grave, che ancora oggi rappresenta una delle principali cause di morte dei pazienti con sclerodermia. Bisogna pertanto giocare sulla prevenzione, spiando con costanza i primi segni di insorgenza dell’ipertensione polmonare, e controllarla poi con le opportune terapie.
Il paziente con Sclerosi Sistemica presenta non raramente un interessamento primitivo anche del cuore e del pericardio. La fibrosi cardiaca può provocare disturbi del ritmo e alterazioni della funzione di pompa del cuore.
Infine, può esserci, ma è piuttosto rara, anche una localizzazione renale della malattia, con improvvisa comparsa di crisi ipertensive e l’instaurarsi di un’ipertensione arteriosa grave particolarmente resistente alla terapia, accompagnata da insufficienza renale che evolve rapidamente verso la dialisi.
6839
Diagnosi – Sclerosi Sistemica
Sclerosi sistemica e fenomeno di Raynaud: quale legame?
Se è vero che tutti i soggetti affetti da Sclerosi Sistemica (SSc) hanno il fenomeno di Raynaud, non è affatto vero il contrario: meno del 5% dei malati con fenomeno di Raynaud sviluppano con 1’andar del tempo la Sclerosi Sistemica. Le cause del fenomeno di Raynaud sono infatti diverse e, in alcuni casi, facilmente individuabili:
1. Idiopatico
2. Esposizione ambientale lavorativa (vibrazioni, tossici ambientali)
3. Farmaci (Alcaloidi della segale cornuta, betabloccanti)
4. Malattie del tessuto connettivo, compresa la sclerodermia
5. Malattie vascolari degenerative o infiammatorie
6. Arteriosclerosi
-Tromboangite obliterante (malattia di Buerger)
-Vasculiti su base immunitaria
7. Alterazioni ematologiche
-Crioglobulinemia
-Agglutinine fredde
-Stati di iperviscosità
8. Cause anatomiche (possono causare un fenomeno di Raynaud unilaterale)
-Costola cervicale soprannumeraria
-Aneurisma dell’arteria subclaveare.
Il problema sorge quando non vi è nessuna causa apparente, soprattutto nel sesso femminile. Il fenomeno di Raynaud idiopatico è infatti molto frequente nella popolazione femminile, proprio quella che è maggiormente colpita da SSc. La diagnosi differenziale si complica ulteriormente se si tiene conto che nei pazienti con SSc, il fenomeno di Raynaud può precedere anche di anni le prime manifestazioni sclerodermiche.
Un aiuto importante alla diagnosi precoce è rappresentato dalla presenza degli autoanticorpi che sono tipici della SSc, oltre che dal risultato di alcuni importanti esami strumentali, in particolare la capillaroscopia. Sono però importanti alcuni indizi clinici che il medico deve essere pronto a cogliere. Il fenomeno di Raynaud del paziente sclerodermico, anche nella fase di pre-sclerodermia, è grave, si accompagna spesso a lesioni trofiche e non è stagionale, insorge cioè per temperature ambientali non particolarmente basse, anche d’estate.
6840
![]()
Fare diagnosi di Sclerosi Sistemica: le domande più comuni
Fare diagnosi tempestiva e precoce di sclerodermia è molto importante per la scelta della terapia più adeguata e per una prognosi favorevole. Ecco le risposte alle domande più frequenti.
È difficile fare diagnosi di Sclerosi Sistemica? In presenza di malattia conclamata, tra tutte le connettiviti, la Sclerosi Sistemica è forse quella che presenta minori difficoltà di diagnosi. Le lesioni cutanee, fondamentali per una corretta diagnosi, sono infatti inconfondibili. Il problema si presenta nei soggetti che sono affetti da quella variante molto rara della malattia che è la Sclerodermia sine Scleroderma e in quelli, molto più numerosi, che presentano come unico sintomo il fenomeno di Raynaud.
Nel primo caso l’attenzione del medico è attirata dalle conseguenze cliniche delle localizzazioni viscerali. Negli altri casi la diagnosi precoce è indubbiamente più difficile.
La malattia conclamata è uguale in tutti i pazienti? La diversità di evoluzione corrisponde anche a una diversa espressività clinica della malattia conclamata. Sulla base dell’estensione del coinvolgimento cutaneo all’esordio, i malati sono suddivisi in 3 gruppi: i pazienti con SSc diffusa (20-25% circa), SSc limitata (70-75%), Sclerodermia sine Scleroderma (meno del 10%). In quest’ultimo gruppo sono presenti le manifestazioni viscerali tipiche della Sclerodermia Sistemica ma manca la compromissione cutanea. I pazienti con Sclerodermia diffusa hanno in genere un coinvolgimento viscerale più importante e quindi una prognosi meno favorevole.
Come si riconosce il Raynaud Sclerodermico? Il fenomeno di Raynaud insorge, senza causa apparente, in una donna che ha già superato i 20 anni; in secondo luogo ha un andamento più grave e risponde male alle terapie. Elementi ancora più indicativi sono la presenza di anticorpi tipici della sclerodermia e delle alterazioni dei test strumentali (ecodoppler e capillaroscopia).
Come si fa a capire che la malattia è in piena attività? La presenza dei segni clinici dell’infiammazione (febbre, dolori muscolari e articolari, artrite) e l’aumento degli indici di infiammazione (VES, fibrinogeno) sono segni di attività. In realtà negli sclerodermici, anche in presenza di malattia attiva, questi segni possono mancare, e il giudizio di attività coincide con la dimostrazione dell’evoluzione clinica della malattia. Sono sicuramente indicativi di attività: la gravità del fenomeno di Raynaud e, nelle fasi iniziali, l’entità dell’edema cutaneo. Ne deriva la necessità di utilizzare tecniche di valutazione quantitative adeguatamente sensibili, in modo da poter cogliere variazioni relativamente piccole delle lesioni cutanee e viscerali.
6841
![]()
Sclerosi Sistemica: tutti gli esami
Nella maggior parte dei pazienti con Sclerosi Sistemica sono presenti anticorpi diretti contro il nucleo cellulare: il nucleolo, il centromero, la topoisomerasi I o Scl 70, la RNA-isomerasi, enzimi che hanno un ruolo importante nella trascrizione dell’informazione genetica. Questi anticorpi sono caratteristici della malattia: si trovano raramente in soggetti con altri tipi di connettivite. Sono quindi utili elementi di diagnosi, ma il medico deve sempre tener presente che:
a) l’assenza di anticorpi non esclude la diagnosi
b) la presenza di anticorpi non è sufficiente a fare diagnosi; deve però allertare il medico spingendolo a spiare nel tempo l’eventuale insorgenza di segni sclerodermici.
Oltre ai criteri clinici e agli esami sierologici, per diagnosticare il fenomeno di Raynaud sclerodermico è molto utile la capilloroscopia, un esame strumentale semplice e non invasivo che permette di osservare con un’apposita lente i capillari del letto ungueale. Nel soggetto normale i capillari sono sottili, disposti in maniera parallela; negli sclerodermici i capillari sono diminuiti di numero con zone desertiche; le anse sono distorte e dilatate, vi sono capillari giganti.
Le prove di funzionalità respiratoria con emogasanalisi e diffusione alveolo-capillare del CO sono in grado di evidenziare l’esistenza di alterazioni anche in fase iniziale. L’ecocolordoppler cardiaco può essere utilizzato per monitorare in maniera non invasiva i livelli di pressione polmonare nei soggetti che hanno sviluppato un’insufficienza tricuspidale. La TAC polmonare ad alta risoluzione permette una diagnosi molto precoce e non invasiva di fibrosi polmonare, evidenziando le caratteristiche lesioni a nido d’ape.
ECG ed ecocardio sono in genere strumenti adeguati per la valutazione e il monitoraggio cardiologico degli sclerodermici. Nei doggetti con aritmie e/o disturbi di conduzione è utile l’ECG secondo Holter, mentre le tecniche radioisotopiche sono da riservarsi ai casi in cui l’ecocardiodoppler non ha dato risultati soddisfacenti.
La manometria esofasea e rettale e le tecniche radioisotopiche permettono una diagnosi precoce e quantitativa dell’interessamento sclerodermico. La determinazione della piaccametria/24h e la gastroscopia sono utili per quantizzare l’entità del reflusso gastro-esofageo e del danno mucoso (esofagite). La determinazione del ferro ematico, della transferrina e della ferritina possono essere utili per sospettare l’esistenza di un malassorbimento del ferro. I pazienti con ipoalbuminemia, e/o steatorrea e dimagrimento devono essere sottoposti a indagini specifiche per il malassorbimento.
Il monitoraggio della pressione arteriosa, della creatinemia, dell’azotemia sono, insieme all’esame chimico-fisico e microscopico delle urine, sufficienti per cogliere una eventuale compromissione renale.
La radiografia delle mani è importante nel seguire l’evoluzione della sclerodermia. Permette, infatti, di evidenziare alcune alterazioni tipiche quali la presenza di calcinosi (non ancora affiorate sulla superficie cutanea), una perdita di sostanza ossea con l’accorciamento progressivo delle falangi e l’esistenza di erosioni che possono indicare l’esistenza di un’artrite simil-reumatoide.
L’aumento della VES, del fibrinogeno, delle gamma globuline sono indice di attività di malattia, specie nei pazienti con Sclerodermia diffusa. Negli sclerodermici aumentano anche i livelli di due proteine, il Ca19.9 e il Ca 15.5, due marcatori neoplastici che negli sclerodermici hanno invece il significato dell’esistenza di una fibrosi grave con elevata attività evolutiva.
6842
Cura e Terapia – Sclerosi Sistemica
Dalla Sclerosi Sistemica si può guarire?
Fino a non molto tempo fa la Sclerosi Sistemica era considerata non solo una malattia altamente invalidante ma, per le sue localizzazioni viscerali, una patologia a prognosi infausta. Oggi per fortuna la situazione, anche se non brillantissima, è sicuramente molto più rosea.
Grandi progressi ottenuti nel campo della patogenesi della SSc hanno infatti radicalmente cambiato l’approccio terapeutico: nuove indicazioni per vecchi farmaci, quali la ciclofosfamide, si accompagnano a nuove terapie che modificano l’evoluzione della malattia agendo proprio sui meccanismi della stessa quali i prostanoidi, in particolare l’Iloprost e la prostaciclina, e il bosentan, sostanza che agisce sui recettori dell’endotelina, molecola chiave nella patogenesi della malattia.
Si stanno anche mettendo a punto nuove molecole e testandone altre già esistenti che intervengono antagonízzando le citochine fibrogenetiche, quelle sostanze cioè che innescano e mantengono l’iperattività delle cellule della fibrosi, i fibroblasti. Un esempio è dato dal Sildenafil, meglio noto come Viagra che, efficace nel combattere l’impotenza dell’uomo sclerodermico, sembra dare nella terapia della Sclerodermia risultati importanti.
Un altro elemento che ha cambiato l’aspettativa e la qualità di vita dei malati è la possibilità di diagnosticare la malattia in fase precoce e mettere cosi precocemente in atto tutte quelle misure, di monitoraggio e terapia, necessarie per ostacolare l’evoluzione della malattia e le sue conseguenze.
Al paziente che chiede, dopo la diagnosi, «La malattia può guarire?», si può serenamente spiegare che oggi, se non si può con sicurezza dire che la sclerodermia guarisce, si può però affermare che la malattia spesso si spegne. Questo è tanto più vero quanto più la patologia è diagnosticata precocemente e quanto più è adeguatamente monitorata e curata; è vero infatti che se la malattia si spegne, non si spengono i danni che essa ha provocato.
È quindi molto importante ridurre al minimo i danni che la SSc provoca nelle fasi di attività, in maniera che, quando essa si spenga, le condizioni generali del malato siano le migliori possibili.
6843
![]()
Curare la Sclerosi Sistemica: vecchie e nuove indicazioni
Nessun farmaco influenza significativamente la storia naturale della Sclerosi Sistemica nel suo complesso, ma varie sostanze sono utili nel trattare sintomi organo-specifici. Per esempio:
-i FANS possono essere utili per l’artrite
-i corticosteroidi possono aiutare se vi è evidente miosite o malattia mista del tessuto connettivo
-vari immunosoppressori, tra cui metotrexate, azatioprina e ciclofosfamide, possono aiutare nel caso di alveolite polmonare.
Nella Sclerosi sistemica gli steroidi sono impiegati a dosi relativamente basse quando le condizioni cliniche fanno pensare che si è in una fase di attività infiammatoria. Steroidi a dosi elevate sono impiegati nei pazienti che presentano un’alveolite attiva e che non hanno risposto alla ciclofosfamide. La terapia steroidea evoca purtroppo una lunga lista di effetti collaterali dannosi: aumento dell’appetito e quindi di peso, disposizione del grasso su viso, addome e parte inferiore della nuca, disturbi del sonno e dell’umore, disturbi gastrici, debolezza muscolare. Per fortuna non tutti e non sempre si manifestano e va sottolineato che sono per la maggior parte completamente reversibili con la sospensione del farmaco.
Negli sclerodermici la terapia con steroidi presenta un rischio aggiuntivo: quello della crisi renale sclerodermica, emergenza medica di estrema gravità. Non va quindi usata se non in casi di reale necessità, monitorando con estrema cura la funzione renale, anche con l’aiuto dell’ecodoppler renale.
E per il fenomeno di Raynaud? Negli sclerodermici il fenomeno di Raynaud è particolarmente grave e insorge anche quando le condizioni climatiche sono buone e la temperatura mite. Proteggersi dal freddo con opportuni indumenti ed evitare di uscire nelle ore più fredde sono in genere misure utili ma non sufficienti. A volte non bastano neanche i farmaci vasodilatatori di comune impiego (come la Nifedipina). Le conseguenze sono: disturbi trofici, ulcere, necrosi.
Per ovviare a questi problemi, sono stati introdotti i prostanoidi: il farmaco più usato ed efficace è l’Iloprost che può essere associato, per potenziarne l’azione, anche ai calcioantagonisti e agli antiagreganti o, in particolari pazienti e con molta cautela, agli anticoagulanti orali. Lo svantaggio dei prostanoidi sta nel fatto che permangono in circolo per un periodo piuttosto breve. Per questo è necessario somministrarli in infusione continua per ore, con disagi per il malato ma anche con difficoltà organizzative del centro dove viene effettuata la terapia.
6844
![]()
Sclerosi Sistemica: la terapia per le complicanze
ULCERE INFETTATE
È indispensabile effettuare una terapia antibiotica per via sistemica dopo aver isolato il germe e averne testato la sensibilità agli antibiotici. Nei casi più resistenti è utile il ricorso alla terapia iperbarica.
CALCINOSI
Nei tessuti dove si depositano, le calcinosi possono provocare un’infiammazione molto dolorosa e un’ulcerazione della cute infiammata con fuoriuscita di materiale calcareo. La somministrazione di diltiazem, un farmaco del gruppo dei calciantagonisti, sembrerebbe non solo in grado di prevenire ma anche di far regredire le calcinosi gia esistenti. Ma le segnalazioni sono ancora sporadiche e i soggetti trattati ancora pochi.
ALTERAZIONI GASTROINTESTINALI
Allo sclerodermico vanno sempre prescritti farmaci in grado di ridurre o addirittura bloccare l’acidità della secrezione gastrica e ostacolare il reflusso gastroesofageo dopo i pasti. Sono poi utili quei farmaci in grado di aumentare la motilità gastrointestinale in ogni suo distretto, da assumere prima dei pasti principali. Servono anche misure di carattere generale finalizzate a evitare il ristagno di cibo in esofago: assumere pasti piccoli e frequenti, evitare una posizione completamente supina dopo i pasti e dormire con un paio di cuscini; aumentare il contenuto di acqua nelle feci; usare con regolarità i farmaci prescritti senza aspettare l’insorgenza dei sintomi. Quando è presente diarrea è necessario ricorrere a un’adeguata terapia antibiotica (in genere
con amoxicillina) e alla somministrazione di fermenti lattici. I più utili sono quelli che superano indenni la barriera del succo gastrico e che hanno un altissima concentrazione di batteri buoni.
FIBROSI POLMONARE
Lo scopo in questi casi è cercare di rallentare il più possibile l’evoluzione della fibrosi verso l’insufficienza respiratoria vera e propria. Le armi a nostra disposizione sono la ciclofosfamide o lo
steroide ad alta dose. Questi farmaci vanno però impiegati soprattutto quando vi è un’alveolite fibrosante. La fisioterapia respiratoria può aiutare a conservare il più a lungo possibile una
adeguata funzionalità respiratoria.
IPERTENSIONE POLMONARE
La vera svolta nella terapia di questa complicanza è rappresentato dal bosentan, farmaco che ha il vantaggio di poter essere assunto per via orale: blocca una molecola chiave nella patogenesi della malattia, soprattutto nella quota che riguarda il danno vascolare ed è efficace in molti dei soggetti ai quali viene somministrato. Per il momento è riservato ai malati con ipertensione polmonare grave.
CARDIOPATIA
I farmaci che vengono comunemente usati sono quelli normalmente usati nello scompenso e nelle aritmie. Alcuni di questi farmaci come la digitale e gli antiaritmici devono essere impiegati con estrema cautela perché potenzialmente pericolosi nel soggetto sclerodermico.
INTERESSAMENTO RENALE
Farmaci comunemente impiegati per curare l’ipertensione e lo scompenso cardiaco, gli ace-inibitori, hanno non solo ridotto la mortalità acuta ma anche migliorato la prognosi a lungo termine del danno renale. È possibile oggi, se l’intervento farmacologico e la dialisi sono tempestivi e corretti, che una parte dei malati recuperi un grado tale di funzione renale da poter uscire dalla dialisi.
6845
Glossario per Sclerosi Sistemica – Enciclopedia medica Sanihelp.it
Farmaci
– TRACLEER*56CPR DISP 32MG
– TRACLEER*56CPR RIV 125MG
– TRACLEER*56CPR RIV 62,5MG
Tag cloud – Riepilogo dei sintomi frequenti
sensazione di bruciore
rottura dei capillari
affaticabilità
affanno
tosse
gonfiore
eruttazioni
difficoltà di respiro