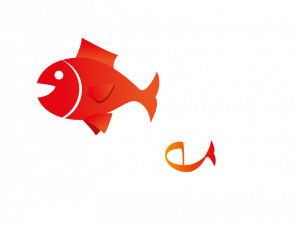Epilessia
La malattia è anche conosciuta come:
convulsioni, grande male, mal caduco, morbo comiziale, morbo sacro
INDICE
Grazie al contributo della Lega Italiana Contro l’Epilessia (www.lice.it) facciamo luce sull’epilessia, malattia neurologica diffusa a tal punto da essere considerata malattia sociale.
Categoria: Malattie neurologiche
Che cos’è – Epilessia
Epilessia: una malattia sociale
Grazie al contributo della LICE (Lega Italiana Contro l'Epilessia) scopriamo che l’epilessia è una malattia neurologica che si esprime in forme molto diverse tra loro. Questa pluralità prevede anche prognosi diverse: la maggior parte delle forme di epilessia è compatibile con una vita normale; le altre forme, più rare, sono invece di maggior gravità. Il termine epilessia deriva dal greco e significa essere sopraffatti, essere colti di sorpresa.
L'epilessia è una delle più diffuse malattie neurologiche, tanto da essere considerata una malattia sociale. Non è facile stimare la frequenza dell'epilessia, perché spesso questa malattia viene tenuta nascosta per motivi psicologici e ambientali. Nei Paesi industrializzati l’epilessia interessa circa una persona su 100: si stima che in Europa circa sei milioni di persone abbiano un’epilessia in fase attiva e che la malattia interessi in Italia circa 500.000 persone.
I maggiori picchi di incidenza si hanno nei bambini e nei giovani adulti e negli anziani. Nei Paesi in via di sviluppo l’incidenza dell’epilessia è maggiore, anche se non vi sono dati epidemiologici sicuri.
13741
![]()
Cause e fattori scatenanti
La Lega Italiana Contro l'Epilessia ci aiuta a comprendere le cause e i fattori che scatenano la malattia: l'insorgenza dell'epilessia si ritiene avvenga per cause genetiche. La malattia può però anche essere causata da un danno cerebrale prima o subito dopo la nascita (per esempio per un difetto di ossigenazione del cervello nei primi attimi di vita o per un parto difficile), da malformazioni del cervello (per un errore di sviluppo), da malattie infettive del sistema nervoso (encefaliti), da traumi cranici gravi (per incidenti stradali), da tumori cerebrali, da ictus (soprattutto negli anziani) e da malformazioni dei vasi cerebrali.
Molti fattori esterni possono inoltre facilitare la comparsa, in un soggetto predisposto, di una crisi epilettica, occorre pertanto prestare attenzione. Sempre nei soggetti predisposti, le crisi epilettiche possono comparire dopo stress psico-fisici eccessivi o in seguito a importanti modificazioni del ciclo sonno-veglia (veglie prolungate, risvegli precoci). Anche l’eccessiva assunzione di alcol o di droghe (cocaina) può facilitare la comparsa di crisi.
Alcuni soggetti sono particolarmente sensibili all’effetto di luci intermittenti sia artificiali (luci al neon, luci psichedeliche, schermi televisivi), sia naturali (passaggio lungo un viale alberato, riflesso del sole sull’acqua o sulla neve).
I soggetti predisposti all’epilessia, in cui questa suscettibilità agli stimoli visivi sia particolarmente spiccata, possono soffrire di crisi davanti alla TV o mentre giocano ai videogames e questo è un fattore che preoccupa in genere molto i genitori di bambini con epilessia. In questi casi è utile seguire alcuni accorgimenti:
• illuminare l’ambiente circostante
• non stare troppo in prossimità dello schermo
• dotarsi di schermi a 100 Hz e più
• limitare il tempo trascorso davanti alla TV
Nel caso dei videogiochi va considerato anche il ruolo dello stress emotivo legato al gioco stesso e l’intensità e il tipo di colore delle immagini: in questo caso bisogna evitare che i bambini giochino troppo vicini allo schermo e per periodi troppo lunghi.
Questa importante sensibilità alla luce non è presente in tutte le forme di epilessia. Nella maggior parte dei casi la luce intermittente non provoca le crisi.
13747
Sintomi – Epilessia
Le crisi epilettiche
Come spiega la Lega Italiana Contro l'Epilessia (LICE), le epilessie si manifestano attraverso sintomi diversi, che costituiscono le cosiddette crisi: un disturbo improvviso e transitorio, che dipende da un’alterazione della funzionalità delle cellule nervose, i neuroni. I neuroni comunicano tra loro attraverso impulsi elettrici generati da scambi biochimici tra le cellule: se i neuroni diventano iperattivi, scaricano impulsi elettrici in modo eccessivo e possono determinare una crisi epilettica.
Per crisi epilettica si intende la risposta non specifica del cervello a vari danni a carico del cervello; le epilessie possono quindi avere una moltitudine di cause differenti. Convenzionalmente una diagnosi di epilessia richiede che il paziente abbia avuto almeno due crisi spontanee.
Le crisi possono essere parziali (o focali) e generalizzate. Le prime iniziano in una zona circoscritta di cellule nervose in un emisfero del cervello da cui possono propagarsi ad altre aree cerebrali; le seconde coinvolgono fin dall’inizio i due emisferi cerebrali.
L'esempio più noto, sebbene il non più frequente, di crisi generalizzata è la crisi convulsiva (detta di Grande Male), in cui il paziente perde coscienza improvvisamente, può emettere un urlo, cade a terra irrigidito, è colto da scosse su tutto il corpo, può morsicarsi la lingua o perdere le urine.
Altre distinzioni vengono fatte sulla base dei sintomi associati alla crisi, quali contrazioni dei muscoli, sensazioni alterate (sintomi soggettivi o aure), perdita di coscienza. La maggior parte delle crisi epilettiche, che possono essere isolate o in serie, dura da pochi secondi a pochi minuti.
Le sindromi epilettiche sono caratterizzate da una serie di sintomi e segni che si manifestano insieme e costituiscono una particolare condizione clinica; la loro classificazione permette di indirizzare a una cura e determinare la prognosi. Si distinguono epilessie generalizzate e localizzate, sintomatiche (dovute a malformazioni, traumi, tumori) e idiopatiche (causate da un difetto
genetico); ci sono inoltre sindromi in cui l’insorgenza è in relazione all’età e sindromi per cui non sussiste tale relazione.
Una sola crisi epilettica, anche se drammatica e preoccupante, non significa che la persona coinvolta abbia l'epilessia. Può caèitare infatti, nel corso della vita, di avere una crisi epilettica, senza che si ripeta in altre occasioni. Nell’epilessia invece le crisi tendono a ripetersi nel tempo in modo spontaneo, con frequenza diversa e non sempre prevedibile.
Alcune forme di epilessia sono caratterizzate da un solo tipo di crisi, che si ripetono sempre allo stesso modo e spesso anche nello stesso periodo della giornata. In altri casi invece le crisi si modificano nel tempo: un soggetto può avere un tipo di crisi da bambino e un altro tipo nell’età adulta. Infine in certe forme di epilessia un soggetto può avere più tipologie di crisi.
13746
Diagnosi – Epilessia
La diagnosi di epilessia
Se si sospetta un’epilessia, è consigliabile, secondo le indicazioni della Lega Italiana Contro l'Epilessia, rivolgersi a Centri e Laboratori specialistici, che provvederanno a fare diagnosi di epilessia e a stabilire di che tipo di epilessia si tratta.
Nel formulare le prime ipotesi diagnostiche, il primo passo è l’interrogatorio clinico, spesso con l’ausilio dei familiari o di chi ha assistito alle crisi. L'esame di laboratorio più valido e utilizzato in campo diagnostico è l’elettroencefalogramma (EEG): di facile esecuzione, non provoca disagi particolari al paziente, è poco costoso e non nocivo. L’EEG registra, attraverso gli elettrodi posti sulla testa del paziente, l’attività elettrica propria del cervello.
Oltre l’EEG standard, esistono poi metodiche più avanzate, in cui è possibile filmare contemporaneamente il soggetto che si sta sottoponendo a una registrazione EEG, visualizzando in modo sincronizzato su uno schermo sia l’immagine reale del soggetto che il tracciato in scorrimento. Questa tecnica, detta Video-EEG, è utile quando è necessario filmare le crisi del paziente e analizzare le corrispondenti modificazioni dell’EEG.
Grazie a piccoli registratori portatili è inoltre possibile la registrazione EEG per periodi molto prolungati (24-48 ore) in soggetti in movimento, che trascorrono una vita del tutto normale nel proprio ambiente (EEG Dinamico).
La TAC cerebrale e la risonanza magnetica cerebrale sono complementari agli studi EEG; se l’EEG fornisce informazioni riguardo al funzionamento del cervello, le neuroimmagini ne mostrano la conformazione dal punto di vista strutturale. Uno studio di neuroiimagine adeguato può chiarire un quesito diagnostico ed essere estremamente rilevante nella strategia terapeutica di un’epilessia. Va ricordato inoltre che la risonanza magnetica è un esame innocuo e può essere ripetuto più volte.
13748
Cura e Terapia – Epilessia
La terapia farmacologica
Come illustra la LICE (Lega Italiana Contro l'Epilessia), il primo approccio alla cura dell’epilessia è sempre farmacologico e ricorre all’utilizzo di farmaci specifici (antiepilettici). Fino al 1990 si avevano a disposizione solo pochi farmaci antiepilettici (ora definiti tradizionali), mentre in seguito sono entrate in commercio farmaci antiepilettici di nuova generazione. L’obiettivo della ricerca farmacologica applicata alla clinica è sempre quello di trovare il farmaco antiepilettico ideale le cui due caratteristiche fondamentali sono: l'efficacia su gran parte delle forme di epilessia e l'induzione di meno effetti collaterali possibili.
Per una buona riuscita del trattamento sono necessarie l’affidabilità e la collaborazione del paziente e dei suoi familiari, la cosiddetta
compliance. Per stabilirla, l’epilettologo (il medico specializzato nella diagnosi e terapia dell’epilessia) deve spiegare con chiarezza le basi fondamentali della cura antiepilettica: si tratta di una terapia molto lunga, generalmente di più anni, che non va mai interrotta e che deve essere assunta spesso anche in 2-3 dosi giornaliere, a intervalli piuttosto regolari.
È opportuno inoltre che il paziente conosca gli effetti dei farmaci somministrati (sia quelli positivi sia quelli negativi) e le eventuali interazioni con altri farmaci che sta assumendo per altri disturbi. Il soggetto dovrà anche essere informato della necessità di eseguire periodiche analisi del sangue per verificare gli effetti sull’organismo in generale e per documentare il livello nel sangue del farmaco stesso. In alcuni casi può risultare difficile convincere un paziente che ha già ottenuto un ottimo successo terapeutico (le crisi sono subito scomparse dopo l’inizio del farmaco) a proseguire la cura per anni.
I farmaci guariscono dall'epilessia? Per guarigione completa si dovrebbe intendere la scomparsa totale delle crisi, anche dopo la sospensione della terapia. In alcune condizioni epilettiche questo può verificarsi; tuttavia in molte altre situazioni in cui si arriva a sospendere la cura, si possono avere delle ricadute.
Nonostante il trattamento adeguato con tutti i farmaci a disposizione nel 15-20% dei soggetti con epilessia non si riesce a ottenere
un controllo soddisfacente delle crisi: in questi casi si parla di farmaco-resistenza. Questo termine designa quella situazione in cui, pur essendo state tentate tutte le cure le crisi non scompaiono.
Dei pazienti che sono resistenti ai farmaci, il 15-20% potrebbe trarre beneficio da un intervento neurochirurgico.
Può esistere anche una farmacoresistenza falsa, dovuta a diagnosi errata con scelta inadeguata del farmaco, a mancato impiego di farmaci potenzialmente indicati per quel tipo di epilessia, ad assunzione impropria della terapia da parte del paziente.
13749
Chirurgia – Epilessia
Gli interventi neurochirurgici
Grazie alla Lega Italiana Contro l'Epilessia affrontiamo il tema della chirurgia nell'epilessia e spieghiamo gli obiettivi dell'intervento neurochirurgico e le attenzioni da mantenere.
Il trattamento chirurgico è proponibile solo nelle epilessie farmacoresistenti con crisi focali. Considerazioni particolari si applicano a bambini che presentano forme di epilessia particolarmente gravi. La chirurgia dell'epilessia comprende qualsiasi intervento neurochirurgico con lo scopo di migliorare un’epilessia non trattabile con farmaci, abolendone o riducendone significativamente le crisi, senza procurare effetti collaterali neurologici.
Chi soffre di sindromi epilettiche con bassa probabilità di risposta al trattamento medico e una prognosi chirurgica favorevole dovrebbe essere preso in considerazione precocemente per una terapia chirurgica, sia per evitare che il trattamento continuato con farmaci privi o quasi di effetto terapeutico abbia conseguenze psichiche e sociali gravi, sia per frenare l’evoluzione progressiva di alcune sindromi o la comparsa di altre possibili complicazioni.
Prima di intervenire è necessaria un'accurata valutazione per individuare la regione del cervello che genera le crisi del paziente, dimostrando che può essere rimossa con sicurezza senza causare deficit inaccettabili. La chirurgia resettiva è efficace nel 60-70% dei casi.
La chirurgia dell’epilessia richiede la stretta collaborazione di un gruppo di specialisti con competenze diverse e deve essere eseguita in centri con personale e condizioni tecniche appropriate, che comprendono anche metodiche che prevedono registrazioni EEG mediante elettrodi posti direttamente all’interno del cervello, e che rispondano agli standard di qualità necessari per essere accreditati.
Il numero di trattamenti rimane ancora basso: attualmente in Italia vengono operati circa 200-250 pazienti per anno mentre i possibili candidati si aggirano attorno ai 7.000-8.000.
Alcuni pazienti con epilessie farmacoresistenti non possono essere sottoposti a intervento di chirurgia resettiva, perché le crisi originano da più zone del cervello oppure per il rischio di procurare danni neurologici.
In queste situazioni, si può ricorrere a terapie palliative che hanno lo scopo di diminuire le crisi e la somministrazione dei farmaci. Un esempio di terapia alternativa è la stimolazione vagale: tramite un pace-maker sottocutaneo posto a lato del collo vengono inviati degli impulsi al nervo vago, che tendono a diminuire la frequenza delle scariche elettriche del cervello, consentendo (purtroppo solo in una parte dei casi) un miglioramento delle crisi.
13750
Aspetti psicologici – Epilessia
Epilessia non significa malattia mentale
La Lega Italiana Contro l'Epilessia sottolinea come l'epilessia non sia una malattia mentale; evidenzia però come i soggetti con epilessia possano trovarsi in una condizione di disagio psichico. Vediamo perché.
Epilessia non è sinonimo di malattia mentale. In seguito a una diagnosi di epilessia però il paziente deve fronteggiare svariate problematiche psico-sociali che di frequente comportano sintomi ansioso-depressivi i quali, a loro volta, possono anche rischiare di divenire preponderanti rispetto alla patologia di base.
L’individuo deve accettare questa patologia, che al di fuori delle crisi, può essere compatibile con un completo benessere fisico. Egli deve aderire energicamente alle cure che gli sono state prescritte, con un atteggiamento attivo e improntato all’ottimismo sulle prospettive di guarigione. Nei bambini va considerato il possibile effetto negativo dell’iperprotezione familiare e delle possibili discriminazioni in ambiente scolastico, così come negli adulti gli ostacoli frapposti a una corretta integrazione sociale per il radicato pregiudizio e la scarsa informazione sulla malattia.
Le persone interessate da epilessia si trovano quindi spesso in una condizione di disagio psichico da considerare come un effetto
collaterale della malattia stessa. L’epilettologo in genere non è preparato ad affrontarlo e quindi un adeguato sostegno psicologico non può essere che auspicabile, a patto che tra il medico e lo psicoterapeuta ci sia collaborazione e scambio continuo di informazioni.
Particolarmente utili, come in tutte le malattie croniche, sono i gruppi di selfhelp (auto-aiuto) costituiti dai pazienti stessi o dai loro familiari, che si riuniscono tra di loro per confrontare i problemi e tentare di risolverli insieme. Questa modalità di mutuo soccorso tra pazienti e familiari è molto diffusa all’estero e andrebbe stimolata anche nel nostro Paese, dove invece è molto difficile convincere i pazienti, soprattutto quelli con epilessia, a discutere pubblicamente del proprio disturbo e di tutte le sue implicazioni.
13762
Per saperne di più – Epilessia
Crisi epilettiche: cosa fare in caso di…
Cosa fare se si assiste a una crisi epilettica? Ecco le indicazioni stilate dalla Lega Italiana Contro l'Epilessia.
Una crisi epilettica generalizzata di tipo tonico-clonico (la convulsione o cosiddetta crisi di Grande Male) costituisce un evento drammatico che in genere spaventa molto chi la osserva per la prima volta. In realtà questo tipo di crisi non costituisce un pericolo particolare, eccetto che per gli eventuali traumi conseguenti alla caduta improvvisa. Prevenire la caduta è fondamentale, ma purtroppo piuttosto inattuabile vista l'improvvisa comparsa dell'evento.
Ecco cosa fare se il soggetto è a terra:
– Mettere sotto il suo capo qualcosa di morbido, in modo che durante le convulsioni egli non continui a battere ripetutamente la testa.
– Terminate le scosse è utile slacciare il colletto e ruotare la testa di lato per favorire la fuoriuscita della saliva e permettere una respirazione regolare.
– Evitare capannelli di persone. La crisi generalmente è di breve durata, ma una volta terminata il soggetto può essere confuso e non rendersi subito conto dell’accaduto, ha bisogno di riprendersi con calma e certo l’assembramento di persone attorno non è di aiuto.
Di seguito cosa non fare:
– Non tentare di aprire la bocca per impedire il morso della lingua o per evitarne il rovesciamento.
– Non tentare di inserire in bocca oggetti morbidi o rigidi.
– Non bloccare braccia e gambe.
Questi inutili interventi, oltre a provocare lesioni alle dita del soccorritore, potrebbero determinare nel soggetto in crisi lussazioni mandibolari, fratture dentarie e intensi dolori muscolari.
Le crisi epilettiche sono però di diverso tipo e non sempre si manifestano in modo così chiaro. Nel caso delle assenze (il cosiddetto Piccolo Male) per esempio non occorre fare nulla, se non segnalarle.
Altre crisi, come quelle del lobo temporale, si possono manifestare con comportamenti strani e il livello di coscienza può essere parzialmente compromesso; in questi casi è inutile tentare di far tornare in sé il soggetto tormentandolo con continue richieste (egli potrebbe anche comprendere ma essere incapace di esprimersi in modo corretto), così come è sconsigliabile limitargli i movimenti nella stanza (ciò potrebbe determinare reazioni inconsulte). È opportuno limitarsi a vigilare attentamente per evitare che durante
la crisi il soggetto involontariamente non faccia del male a sé e agli altri.
Quando le crisi, di qualsiasi tipo, sono brevi e isolate è inutile chiamare l’ambulanza per portare il paziente in Pronto Soccorso. Il ricovero in ambiente ospedaliero invece è d’obbligo quando la crisi è molto prolungata e il soggetto non riprende coscienza, oppure quando a una prima crisi, dopo qualche minuto, ne segue un’altra e un’altra ancora: questa condizione, definita stato di male epilettico, va affrontata in ambiente idoneo, con somministrazione di farmaci per via endovenosa ed eventuale assistenza da parte del rianimatore.
13761
![]()
L’epilessia infantile e adolescenziale
Grazie al contributo della LICE (Lega Italiana Contro l'Epilessia) proviamo a scoprire cosa comporta l'epilessia nei bambini e negli adolescenti. Il bambino con epilessia ha spesso problemi di inserimento in ambito scolastico che per lo più derivano (almeno nelle forme meno gravi) dall'approccio che i genitori, gli insegnanti e i compagni sviluppano nei confronti di questa malattia. Ii frequente atteggiamento di iperprotezione che i genitori assumono nei confronti del figlio può sfociare in due direzioni: nel nascondere il disturbo anche agli insegnanti o nel parlarne troppo. Gli insegnanti a loro volta sono poco preparati sulla malattia e spesso tendono a drammatizzare, accrescendo il pregiudizio e contribuendo, anche involontariamente, a emarginare il bambino. La paura fondamentale consiste nel non sapere cosa fare se succede una crisi epilettica in classe.
I compagni possono con facilità utilizzare informazioni distorte per scherzare sulla malattia, con ripercussioni psicologiche negative sul bambino stesso, che già di per se ha ridotti livelli di autostima sentendosi malato ma non riuscendo a capire come e perchè.
Per facilitare l’inserimento scolastico del bambino con epilessia sono fondamentali gli interventi educativi e formativi che devono coinvolgere i genitori e gli insegnanti da un lato e il bambino e i suoi compagni dall'altro.
L’epilessia di per sé quindi, almeno quando non è grave, non incide significativamente sulle capacità di apprendimento, mentre le eventuali interferenze negative dipendono prevalentemente da un contesto discriminante. I farmaci antiepilettici invece si ripercuotono sull'apprendimento dei bambini, alcuni più di altri inducono disturbi cognitivi.
Nell’adolescente l’accettazione dell’epilessia è ancora più difficile, la malattia si colloca in un'età in cui le difficoltà del rapporto con il sè sono molteplici. Il ragazzo spesso non si piace e le crisi epilettiche sono viste come un’ulteriore disgrazia, che va ad aggravare una preesistente visione pessimistica riguardo al futuro: è questa un’età di transizione in cui c’è ancora più bisogno di un sostegno psicologico.
13763
![]()
Epilessia in rosa
Gravidanza, parto, allattamento: fasi importanti nella vista di una donna. Vediamo, grazie al contributo della Lega Italiana Contro l'Epilessia (LICE), cosa comporta l'epilessia in questi momenti. L’epilessia colpisce nella stessa percentuale uomini e donne, ma pone alla donna alcuni problemi legati alla contraccezione, alla gravidanza, al parto e all’allattamento.
Se è vero che le donne con epilessia possono assumere la pillola contraccettiva, occorre ricordare però che alcuni farmaci di vecchia generazione (carbamazepina, fenitoina e barbiturici) riducono l’azione contraccettiva della pillola, rendendola meno sicura. Per aumentare il potere contraccettivo bisognerebbe quindi ricorrere a pillole con un più alto contenuto di ormoni estrogeni oppure utilizzare altri sistemi per evitare il concepimento. I nuovi farmaci antiepilettici hanno invece minor interazioni con la pillola contraccettiva.
Non esistono chiare dimostrazioni scientifiche che la donna con epilessia sia meno fertile delle altre, anche se le donne con epilessia fanno meno figli rispetto alla popolazione femminile generale, probabilmente per l’influenza di fattori psico-sociali (difficoltà
nel trovare un partner che accetti la malattia, paura di generare un figlio con lo stesso problema).
L’epilessia non crea problemi rilevanti né durante la gravidanza né durante il parto (che può avvenire tranquillamente in modo naturale), con l’eccezione di tutte quelle situazioni in cui le crisi sono molto frequenti e intense, tanto da poter provocare aborti spontanei o parti prematuri.
Il problema dei farmaci antiepilettici assunti durante la gravidanza riguarda la possibilità di indurre, solo nei primi tre mesi di gravidanza, malformazioni di varia gravità nel feto (il rischio di malformazioni aumenta di 2-3 volte rispetto alla popolazione generale). Vi sono differenze da farmaco a farmaco.
Pertanto è auspicabile che la gravidanza di una donna con epilessia in trattamento con farmaci sia programmata in modo da razionalizzare e semplificare la terapia. Durante tutta la gravidanza il monitoraggio dovrebbe essere attento e regolare con piena collaborazione tra epilettologo e ginecologo.
L'allattamento al seno è consigliabile, anche per i benefici psicologici che ne derivano. I farmaci assunti dalla madre sono in genere scarsamente concentrati nel latte e solo nel caso dei barbiturici e delle benzodiazepine si potranno avere effetti sedativi nel bambino, transitori e di lieve entità. Occorre inoltre considerare che durante la gravidanza i farmaci assunti dalla madre arrivano comunque al feto attraverso il sangue e in realtà, se dopo la nascita il bambino non viene allattato al seno, si potrà avere una vera e propria sindrome da astinenza, forse più sgradita dell’eventuale effetto sedativo dei farmaci.
In seguito al parto, la donna è più esposta al rischio di crisi (stress, alterazione ciclo veglia-sonno) , ma sarà sufficiente prendere precauzioni per evitare cadute del bambino dalle braccia della madre, in caso di crisi.
Infine, le crisi epilettiche possono avere qualche correlazione con il ciclo mestruale, in genere con comparsa o aumento delle crisi proprio nel periodo mestruale. Alcune donne hanno crisi solo ed esclusivamente prima e durante il ciclo e sono questi i casi in cui si parla di epilessia catameniale.
13764
![]()
Anziani ed epilessia
La Lega Italiana Contro l'Epilessia (LICE) ci accompagna alla scoperta dell'epilessia nella terza età: la causa prevalente di epilessia negli anziani sono le lesioni cerebrali dovute a disturbi di circolazione, ma crisi epilettiche si possono anche riscontrare in pazienti con demenza, tumori o altre malattie.
L'epilessia nell'anziano si associa ad altre malattie che necessitano anch’esse di farmaci. Bisognerà quindi tenere in debito conto le interazioni tra i vari medicinali e soprattutto scegliere il farmaco antiepilettico che, pur essendo capace di controllare le crisi, induca la minor quantità di effetti negativi, in particolare quelli di tipo sedativo.
L’anziano con epilessia ha bisogno di personale di supporto che eviti i rischi conseguenti alle cadute in seguito a crisi e che controlli l’assunzione regolare dei farmaci.
13765
Glossario per Epilessia – Enciclopedia medica Sanihelp.it
Farmaci
– ACIDO VALP SAND*30CPR 300MG RP
– ACIDO VALP SAND*30CPR 500MG RP
– BUCCOLAM*OS SOLUZ 4SIR 10MG
– BUCCOLAM*OS SOLUZ 4SIR 2,5MG
– BUCCOLAM*OS SOLUZ 4SIR 5MG
– BUCCOLAM*OS SOLUZ 4SIR 7,5MG
– CARBAMAZEPINA TEVA*50CPR 200MG
– CERETEC*INIET 2FL 0,5MG
– CERETEC*INIET 5FL 0,5MG
– DEPAKIN*40CPR GASTROR 200MG
– DEPAKIN*40CPR GASTROR 500MG
– DEPAKIN*CHRONO 30CPR 300MG RP
– DEPAKIN*CHRONO 30CPR 500MG RP
– DEPAKIN*CHRONO FL30CPR500MG RP
– DEPAKIN*CHRONO FL30CPR500MG RP
– DEPAKIN*EV 4F 400MG+4F 4ML
– DEPAKIN*GRAT 30BUST 1000MG RM
– DEPAKIN*GRAT 30BUST 100MG RM
– DEPAKIN*GRAT 30BUST 250MG RM
– DEPAKIN*GRAT 30BUST 500MG RM
– DEPAKIN*GRAT 30BUST 750MG RM
– DEPAKIN*OS FL 40ML 200MG/ML
– DEPAMAG*40CPR 200MG GASTRORES
– DEPAMAG*40CPR 500MG GASTRORES
– DEPAMAG*OS SOLUZ FL 100ML 10%
– DEPAMIDE*30CPR GASTROR 300MG
– DIACOMIT*FL 60CPS 250MG
– DIACOMIT*FL 60CPS 500MG
– DIACOMIT*OS SOSP 60BUST 250MG
– DIACOMIT*OS SOSP 60BUST 500MG
Tag cloud – Riepilogo dei sintomi frequenti
convulsioni
irrigidimento delle articolazioni
perdita di conoscenza