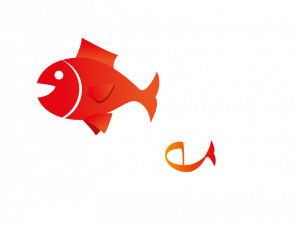Insufficienza Venosa Cronica
INDICE
Colpisce prevalentemente il sesso femminile, complici il sovrappeso e le gravidanze. Tant’è che una donna su due ha le vene varicose. Prevenire si può, basta adottare sane abitudini di vita. E per la terapia, ci sono importanti novità.
Categoria: Malattie cardiovascolari
Sigla: IVC
Che cos’è – Insufficienza Venosa Cronica
IVC: il problema, le cause, i fattori di rischio
Il termine insufficienza venosa cronica (IVC) descrive una condizione che colpisce il sistema venoso degli arti inferiori, con ipertensione venosa che provoca vari disturbi, quali dolore, gonfiore, edema, modificazioni cutanee e ulcerazioni.
È causata da un ridotto deflusso di sangue venoso dalle gambe verso il cuore per dilatazione, allungamento e tortuosità delle vene degli arti inferiori, secondaria a insufficienza congenita o acquisita della parete vasale e delle valvole venose.
Nello stadio più avanzato si possono formare varici. Quelle primitive sono favorite da: sedentarietà, gravidanza, stazione eretta o seduta prolungata. Le varici secondarie sono in genere conseguenti a un processo post-flebitico e/o post-trombotico che hanno determinato insufficienza valvolare.
I fattori di rischio associati all’IVC comprendono l’età, il sesso, la familiarità per vene varicose, l’obesità, la gravidanza, la flebite e precedenti traumi agli arti inferiori.
Possono anche esservi fattori ambientali o comportamentali associati all’IVC, quali il rimanere per lunghi periodi in posizione eretta o in posizione seduta durante il lavoro d’ufficio.
Infatti è ampiamente riconosciuto che alcune occupazioni, particolarmente quelle che obbligano a un prolungato ortostatismo, si associano a una maggior prevalenza di varici, anche se una tale correlazione è estremamente difficile da dimostrare sul piano statistico. Si è esaminata l’incidenza di varici in persone di varie professioni, particolarmente tra gli operai. Un’associazione positiva tra la stazione eretta e le varici è stata dimostrata da diversi autori. Esercita un’influenza anche la temperatura del luogo di lavoro.
L’IVC colpisce prevalentemente il sesso femminile fino alla quinta-sesta decade, successivamente non si notano differenze tra i sessi. Numerosi studi epidemiologici correlano l’incidenza delle varici con la gravidanza e con il numero dei parti. Esse variano dal 10 al 63% in donne con figli rispetto al 4-26% nelle nullipare. Più gravidanze (1-5) comportano un’incidenza di malattia varicosa dell’11-42% con progressione lineare con l’aumento dei parti. La correlazione è ancora più evidente se la donna è già affetta da disturbi venosi.
Il rapporto tra varici e peso corporeo è stato esaminato da vari autori. Persone in soprappeso, specie se di sesso femminile, soffrono maggiormente di IVC e di malattia varicosa rispetto a individui di peso normale, dal 25 a oltre il 70% (in entrambi i sessi),
contro il 16-45%. Le varici si manifestano abitualmente a entrambi gli arti inferiori, dal 39 al 76% dei casi.
6234
![]()
Malattie venose: i 10 fattori di rischio
Nell’incidenza di disturbi venosi ci sono 10 fattori da tenere sotto controllo. Eccoli.
1. Sovrappeso
2. Numero di gravidanze
3. Vita sedentaria
4. Stazione eretta prolungata
5. Ambiente di lavoro caldo
6. Obbligo di mantenere a lungo una posizione seduta
7. Familiarità per malattie venose
8. Gambe pesanti o altri sintomi di malattia venosa
9. Presenza di dilatazioni di vene superficiali alle gambe
10. Sesso femminile. Le malattie venose e linfatiche, infatti, compiscono maggiormente il gentil sesso: si stima, in particolare, che il 50% delle donne soffra di questi disturbi che colpiscono, invece, il 30% degli uomini.
5818
![]()
Vene varicose per una donna su due
L’insufficienza venosa cronica (IVC) ha una vasta diffusione nei paesi occidentali, mentre è quasi completamente sconosciuta nei paesi del terzo mondo, quali Africa, Asia e Oceania. Nei paesi avanzati in media il 30% della popolazione maschile e il 50-55% di quella femminile ne soffre.
In particolare, in uno studio eseguito nell’ambito delle attività del Gruppo di Studio sull’Epidemiologia e Prevalenza delle Flebopatie Croniche della Società Italiana di Angiologia e Patologia Vascolare è emerso che, nel nostro paese, circa 19 milioni di individui soffrono di IVC e questo ne fa la 3° patologia più diffusa (dopo allergie e ipertensione).
Dallo stesso studio è emerso anche che solo 1 paziente su 3 sa di essere malato e viene curato. Infatti, dei pazienti che afferiscono all’ambulatorio del medico di base in una normale giornata lavorativa, circa il 40% è risultato affetto da IVC, indipendentemente dal motivo per cui i pazienti si erano recati dal medico.
In particolare il 44,7% presentava teleangectasie e il 49% varici, ossia stadi già avanzati di patologia, tanto che 1 paziente su 5 di quelli che erano andati dal medico per motivi diversi dall’IVC è stato inviato allo specialista. In realtà i sintomi e segni ci sono: sempre dallo studio epidemiologico è emerso che il dolore, il senso di peso, il gonfiore, il prurito sono molto diffusi (dal 18 al 28% dei pazienti li hanno riferiti), ma non vengono considerati sintomi di una patologia ingravescente.
Secondo un’altra ricerca condotta nei paesi occidentali e pubblicata su Angiology, l’avanzare dell’età rappresenta un fattore decisivo per l’insorgere del problema: oltre i 60 anni quasi il 60% delle donne lamenta disturbi, mentre la percentuale degli uomini si attesta intorno al 35%.
È sufficiente osservare un range di età inferiore, dai 35 ai 40 anni, per comprendere come siano soprattutto le persone più mature a soffrire di varici. In questo intervallo di età il 40% delle donne lamenta questo disturbo, mentre la percentuale maschile scende a circa il 20%.
In base agli studi effettuati nei Paesi avanzati e pubblicati sulle più prestigiose riviste specializzate, anche l’ereditarietà risulta essere un fattore chiave per l’insorgenza delle varici. Si è infatti dimostrato che in soggetti che presentano fattori ereditari l’incidenza delle varici è circa del 50%, mentre è inferiore al 40% se assenti.
Avere dei figli comporta anche un maggior rischio di soffrire di varici in età avanzata. Circa il 35% delle donne che hanno avuto più gravidanze ne soffre, mentre solo il 15% delle donne senza figli lamenta disturbi analoghi.
Secondo la ricerca condotta da un centro di Stoccarda, quasi il 50% delle persone sovrappeso presenta problemi di varici, che invece interessano il 30% dei soggetti con un peso normale.
6236
![]()
IVC, ma quanto ci costi?
L’IVC rappresenta un notevole onere per i servizi di prestazione sanitaria e un’importante voce di costo per la società in ogni paese del mondo. Le vene varicose hanno un impatto significativo sulle risorse della sanità, dal momento che, ogni anno, milioni di persone richiedono interventi medici a causa dei danni provocati dalla malattia.
Le conseguenze più gravi, quali le ulcere venose, hanno una prevalenza stimata pari a circa lo 0,3%, sebbene ulcere attive o guarite siano identificabili in circa l’1% della popolazione adulta. In generale, la prognosi delle ulcere venose non è buona, essendo comuni la guarigione ritardata e la ricomparsa dell’ulcerazione. Oltre il 50% delle ulcere venose richiede terapie prolungate, della durata superiore a 1 anno.
L’impatto socioeconomico dell’ulcerazione venosa è drammatico, portando a una diminuzione della capacità di espletare attività sociali e occupazionali, riducendo, di conseguenza, la qualità di vita e comportando costi finanziari molto elevati.
Il numero di ore lavorative perse ogni anno in Inghilterra e Galles è pari a circa 500.000, mentre negli Stati Uniti (dove 25.000.000 di persone sono portatori di varici) è di 2.000.000 (2.500.000 di IVC e 500.000 di ulcere venose attive). Dati desunti dal servizio pubblico brasiliano dimostrano che fra le 50 malattie più frequentemente citate come causa di assenteismo dal lavoro e regolarmente riconosciute sul piano finanziario col rimborso, l’IVC è al 14° posto essendo la 32° causa di inabilità permanente.
I costi annuali per la gestione dell’IVC, aggiornati al 2003 e quindi sicuramente in difetto, sono stimati in 290 milioni di Sterline in Gran Bretagna, 2.241.000.000 di euro in Francia, 1.237.326.000 di euro in Germania, 845.956.400 euro in Italia e 103.614.400 euro in Spagna. Inoltre viene stimato che per i principali Paesi europei la Comunità Europea abbia stanziato l’1,5-2% dell’intero budget sanitario del 1992 esulando dai costi indiretti dovuti all’invalidità.
Il costo annuale per la cura delle ulcere venose nel Regno Unito è di circa 400-600.000.000 sterline (40.000.000 per il solo materiale di medicazione), oltre 1 miliardo di dollari negli USA (300.000.000 di dollari solo per le cure domiciliari), 204.520.000 euro in Germania e 32.940.000 euro in Svezia, mentre in Francia il trattamento di una singola ulcera comporta una spesa media di 36.000 euro all’anno.
In Italia si effettuano circa 291.000 visite all’anno per lesioni ulcerative con prescrizioni di farmaci nel 95% dei casi e onere pari a 125.499.026 euro all’anno. Nel nostro paese inoltre la spesa per l’elastocompressione è a carico del paziente, e vengono prescritte ogni anno circa 500.000 paia di calze terapeutiche, contro i tre milioni della Germania ed i 6 milioni della Francia.
Complessivamente il costo diretto e indiretto dell’IVC è di circa un miliardo di euro per ogni Stato europeo di cui si disponga di maggiori dati (Regno Unito, Francia, Germania).
6235
Prevenzione – Insufficienza Venosa Cronica
IVC: decalogo di prevenzione
La lotta alla IVC parte da una corretta attività di prevenzione primaria. Infatti alcune misure profilattiche possono, almeno in parte, ostacolare l’insorgenza della malattia. Schematizzando è possibile attuare una prevenzione:
• delle varici primitive
• della tromboflebite superficiale
• della trombosi venosa profonda
• delle varici secondarie.
I semplici accorgimenti da seguire sono:
1. Evitare di indossare indumenti o cinture troppo stretti (aumentano la pressione endoaddominale), così come scarpe con tacchi a spillo o superiori ai 5 cm.
2. Allo scopo di favorire il deflusso di sangue dagli arti inferiori, riposare durante la notte tenendo le gambe sollevate rispetto al piano del cuore di circa 5 cm. Di giorno sedersi in modo che le gambe possano muoversi e su sedie adeguate. In caso di posizione stazionaria prolungata, compiere ogni tanto dei movimenti di flesso-estensione della caviglia o sollevarsi ripetutamente sulla punta dei piedi.
3. Camminare almeno mezz’ora al giorno, preferibilmente su un terreno soffice. Infatti la sedentarietà non solo fa ingrassare, ma soprattutto implica l’inattività delle pompe muscolari che a sua volta favorisce la stasi ematica a livello degli arti inferiori e quindi fa insorgere o aggrava l’IVC.
4. Evitare gli sport che comportano brusche e violente contrazioni dei muscoli del polpaccio, quali il tennis e lo squash, oppure che aumentano in maniera prolungata la pressione endoaddominale, come il sollevamento pesi o l’equitazione.
5. Adottare tutte le misure dietetiche necessarie a combattere la stitichezza.
6. Terminare il bagno o la doccia con abluzioni di acqua fredda.
7. Indossare una contenzione elastica adeguata: calze contenitive nel caso di soggetti a rischio ancora asintomatici (parrucchieri, camerieri, commessi, hostess) e calze elastiche nel caso di pazienti con varici.
8. In caso di assunzione di pillola anticoncezionale, a scopo preventivo, eseguire esami per identificare una trombofilia familiare ed assumere farmaci flebotropi come i flavonoidi micronizzati.
9. Evitare i bagni caldi, le saune e le cerette a caldo. Evitare l’esposizione prolungata delle gambe al sole.
10. Assumere sia d’estate che d’inverno, nei tempi e modi prescritti dal medico, farmaci flebotropi di provata efficacia clinica ed indicati dalle Linee Guida per l’IVC come la Frazione Flavonoica Purificata Micronizzata (FFPM).
6241
![]()
Come si prevengono trombosi e linfedemi?
L’IVC è una patologia dalle varie gradazioni di gravità. Per questo è importante individuarla e diagnosticarla in tempo, prima che la situazione degeneri in gravi patologie, come la trombosi venosa profonda (TVP), il tromboembolismo venoso e i linfedemi.
TROMBOEMBOLISMO VENOSO. Consiste nel distacco di un grumo di sangue (embolo), formatosi in un punto del sistema circolatorio, solitamente le vene profonde delle gambe, che raggiunge il circolo polmonare occludendolo parzialmente o totalmente. Questo evento, denominato embolia polmonare, può essere improvvisamente fatale per il paziente.
La prevenzione di questi eventi è basata sull’adozione di alcune abitudini di vita, nonché sull’uso di calze a compressione graduata. Infatti i risultati di una ricerca elaborata dal Cochrane Institute e condotta su 1.205 soggetti a medio ed elevato rischio TVP che hanno utilizzato le calze a seguito dell’intervento chirurgico, hanno dimostrato una significativa riduzione del rischio di TVP pari al 66%; inoltre, su altri 1.006 pazienti, cui oltre alla calza elastica era stata suggerita anche una terapia farmacologia, la percentuale arriva ben al 76%.
Anche per i pazienti con livello di rischio più basso è caldamente consigliato il ricorso alle calze, mentre per quelli con rischio intermedio ed elevato si suggerisce di associare alla terapia compressiva anche la profilassi eparinica, utile per evitare la coagulazione del sangue e quindi l’insorgenza di trombi.
LINFEDEMA. È una malattia cronica causata da un difetto del sistema linfatico a cui segue un accumulo di linfa nello spazio interstiziale. I linfedemi possono essere: primitivi, se dovuti a carenza congenita di vasi linfatici, o secondari, se successivi a infezioni. Il linfedema può insorgere anche in fase post-chirurgica, sia all’arto superiore per interventi di mastectomia, che all’arto inferiore, per operazioni ginecologiche o urologiche, immobilizzazione forzata o scarsa mobilità dell’arto.
Il linfedema primitivo non ha possibilità di prevenzione, in quanto il suo esordio è improvviso; la prevenzione è volta a evitare le complicanze infettive e a bloccarne l’evoluzione macroscopica, ovvero l’aumento del volume dell’arto. Nei casi non ancora complicati, questi fini sono raggiungibili mediante kinesiterapia, ovvero la rieducazione funzionale degli arti, e dall’uso di materiale compressivo: bendaggi multipli, tutori elastici e calze elastiche.
Nel mondo sono circa 150 milioni i casi di linfedema, il 21,7% dei quali è collocato negli arti superiori e il 79% negli arti inferiori. La maggior parte dei linfedemi è di tipo parassitario (45 milioni di casi); i restanti si dividono in linfedema secondari a chirurgia o a trauma (25 milioni) e i linfedema primitivi (5-20 milioni).
In Italia i linfedemi primitivi rappresenterebbero il 30-40% del totale (60.000 casi). I linfedemi secondari sono rappresentati per il 40% (36.000 pazienti), dai post-mastectomia.
Alcune recenti ricerche pubblicate su Australian and New Zealand Journal of Phlebology hanno dimostrato che una combinazione del trattamento farmacologico e fisico-compressivo giova al benessere delle gambe, prevenendo e riducendo i linfedemi. La terapia fisico-compressiva si suddivide in due fasi: la prima è rivolta alla riduzione del carico linfatico dell’arto con conseguente diminuzione volumetrica; la seconda fase, mediante l’utilizzo quotidiano della calza elastica, ha la funzione di stabilizzare ed eventualmente migliorare i risultati ottenuti.
6242
![]()
IVC: i costi si riducono prevenendo l’ulcera
L’Insufficienza Venosa Cronica (IVC) è una patologia temibile e sottovalutata con un forte impatto socioeconomico.
Una buona parte dei considerevoli costi è da attribuire a una complicazione frequente della patologia venosa: l’ulcera. In Italia, si effettuano circa 291.000 visite/anno per lesioni ulcerative con prescrizione di farmaci e medicazioni nel 95% dei casi e un onere pari a 126 milioni di euro.
L’ulcera venosa è una lesione cutanea cronica che non tende alla guarigione spontanea. È causata nella maggior parte dei casi dall’IVC (il 50 – 70% di tutte le ulcere cutanee degli arti inferiori sono infatti di origine venosa) e potrebbe essere prevenuta, evitata o ritardata ponendo maggiore attenzione alla patologia venosa.
L’ulcera venosa interessa sia gli strati superficiali della cute (epidermide e derma), che il tessuto sottocutaneo più profondo. Si tratta di uno stadio avanzato della patologia venosa, di difficile risoluzione e che tende a recidivare con grande facilità. Il 50-75% delle ulcere ripara in 4-6 mesi, circa il 20% resta aperto a 24 mesi e l’8% è ancora presente a 5 anni. Colpisce in maniera omogenea sia le donne che gli uomini e si verifica tanto più frequentemente con l’aumentare dell’età (in particolare dai 50 ai 70 anni); per il 12,5% dei pazienti ancora in età lavorativa è addirittura una causa di prepensionamento.
Eppure, prevenire l’Insufficienza Venosa Cronica (IVC) è semplice e può essere attuato attraverso 3 percorsi:
1. Il primo è l’informazione al cittadino, un incarico, questo, demandato alle Società Scientifiche, al medico di base e, da alcuni anni, in modo proficuo quando è corretta, ai Media.
2. Il secondo percorso è affidato alla Ricerca Scientifica, per stabilire con chiarezza la familiarità o l’ereditarietà della malattia.
3. Al terzo posto c’è la terapia che è composta da 2 pilastri fondamentali: i farmaci flavonoidi di provata efficacia clinica e la compressione elastica, cioè la Frazione Flavonoica Purificata e Micronizzata (FFPM) e le calze elastiche.
Attuando questa prevenzione il costo per ogni cittadino è di 1,08 € al giorno. Al contrario, se si aspetta che insorgano le complicanze come l’ulcera, il costo sale a 350 € al giorno.
6237
![]()
Vademecum per gambe in viaggio
Impiegate, autiste, sarte, oppure parrucchiere, cuoche, casalinghe: le prime costrette a lavorare tutto il giorno sedute, le seconde a stare ore e ore in piedi. Entrambe le situazioni non sono favorevoli per il benessere delle gambe, a rischio di sviluppare malattie venose. L’e-thrombosis in particolare è una vera insidia per le gambe di chi lavora seduto, come dimostrano alcune ricerche condotte nel 2005 e pubblicate su European Respiratory Journal.
Ma se pensate che almeno in vacanza le gambe possano tirare un sospiro di sollievo, non c’è da rincuorarsi: anche lunghi spostamenti in auto o aereo costituiscono un potenziale pericolo per le gambe. Insomma, dall’inverno all’estate, dalla città alle spiagge, la circolazione del sangue non ha proprio tregua. Più colpito il gentil sesso, specie a seguito di un parto. Importanti fattori di rischio anche il carattere ereditario e l’obesità.
Come emerge da un lavoro pubblicato su The Lancet nel 2006, quando si superano le 4 ore di aereo si ha un pericolo per le gambe, per due fattori: il tempo in cui si rimane fermi e il calore diretto sulle gambe.
Per dare beneficio alle gambe durante un viaggio può essere utile rispettare queste regole:
-indossare scarpe comode
-alzarsi più volte per brevi passeggiate
-eseguire alcuni movimenti delle caviglie (sollevamenti ritmici sulla punta dei piedi)
-usare pedane inclinate o poggiapiedi mobili
-sollevare ogni tanto le gambe
-non tenere le gambe accavallate.
Attenzione: non cedete alle leggende metropolitane! Le gambe in viaggio non hanno bisogno di aspirina (come purtroppo si è letto!), bensì di mobilizzazione. Un aiuto in questo senso può venire dall’uso di calze a elastocompressione graduata, che in caso di sedute forzate e prolungate esercitano una compressione sulla circonferenza degli arti, facendo fluire il sangue dal circolo superficiale a quello profondo. Contenzione non significa stringere le gambe per contrastare una malattia già presente, ma contenerle nel senso di evitarla o di donare benessere.
Suddivise in varie tipologie come il gambaletto, la calza a mezza coscia, le calze, il monocollant e i collant, queste calze aiutano in caso di inestetismi femminili come ritenzione idrica e cellulite. Non solo: sono i principali strumenti usati dai medici nelle terapie per la cura delle gambe, prevenendo anche dal rischio di gravi patologie, come la trombosi venosa profonda (TVP), il tromboembolismo venoso e i linfedemi.
E se solo l’idea di uno massiccio tutore ortopedico vi fa inorridire, dovete ricredervi: oggi, grazie alla ricerca sui materiali e sulle forme, questi tutori sono anche esteticamente attraenti. Una buona vestibilità, soprattutto per i livelli di compressione più elevati, la facilità a reperire la taglia esatta, il comfort, in particolare nei climi caldi o nella stagione estiva, sono le caratteristiche fondamentali che una calza deve possedere per la riuscita della terapia elastocompressiva.
A prova di vacanza!
5817
Sintomi – Insufficienza Venosa Cronica
Le due fasi della IVC
L’insufficienza venosa cronica può manifestarsi inizialmente con semplici sintomi localizzati nella parte inferiore della gamba e nella caviglia, quali dolore, senso di pesantezza, gonfiore serale, crampi muscolari notturni, anche senza i segni evidenti della patologia.
Uno stadio più grave della malattia, che compare se non si interviene tempestivamente, comprende manifestazioni come vene cutanee dilatate, teleangectasie, vene reticolari e vene varicose, fino a uno stato di atrofia cutanea con ulcerazione.
L’IVC non si associa necessariamente a disturbi invalidanti. Questo non giustifica tuttavia un atteggiamento, oggi molto diffuso, di sottovalutazione della malattia e trascuratezza dei sintomi. Molto spesso infatti i pazienti sopportano i crampi notturni alle gambe, il prurito e il gonfiore non associandoli a una malattia, ma a una semplice situazione di stanchezza, stress o posizione eretta troppo prolungata. È come se la malattia non venisse realmente percepita, attribuendone i disturbi a situazioni transitorie.
La sottovalutazione di questi sintomi fa sì che la persona si rivolga al medico tardi, solo quando compaiono segni visibili (capillari e vene dilatati) e la malattia è già in una fase molto avanzata.
6243
Diagnosi – Insufficienza Venosa Cronica
IVC: cosa può fare il medico?
L’IVC è una malattia spesso sottovalutata e non correttamente identificata dal paziente. Le persone, in modo particolare le donne, non sono molto informate sui rischi che si nascondono dietro ai primi segni della malattia, quelli ritenuti erroneamente solo antiestetici. Non dando grande importanza a questi segni, e per di più, davanti al costo dei farmaci, vengono considerati solo inestetismi legati all’età che avanza, tramutandosi così nel tempo in patologie gravi, con necessità di ricovero ospedaliero.
Dobbiamo però ricordare che alla sottovalutazione individuale si associa talvolta quella del medico, che non sempre si adopera per effettuare una diagnosi approfondita. Non è infatti abitudine del medico di medicina generale osservare le gambe di ogni paziente che presenta fattori di rischio.
Questo atteggiamento può avere conseguenze anche gravi. Infatti, se trascurata, l’IVC può dare origine a complicanze importanti (rallentamento sanguigno e ipercoagulabilità) che richiedono talvolta l’intervento chirurgico. Le varici sono la conseguenza più rilevante della patologia, perché possono ulcerarsi e causare problemi di funzionalità degli arti inferiori.
Fino alle complicanze più drammatiche: dall’ulcerazione della cute, alla tromboflebite o alla lipodermatosclerosi, o addirittura tragicamente all’embolia polmonare, che mette a repentaglio la vita stessa.
Senza dimenticare l’impatto sociale in termini di giornate lavorative perse: l’impossibilità di stare in piedi è infatti una delle conseguenze più importanti della IVC non curata correttamente.
Cosa può fare il medico di medicina generale per prevenire questi effetti? Il medico deve:
1. Individuare i soggetti a rischio (donne multipare, lavoratori che stanno molto tempo in piedi, soggetti in sovrappeso).
2. Far capire loro che la piccola vena antiestetica di oggi si può trasformare in un’ulcera domani e perfino in un’embolia polmonare dopodomani.
3. Visitarli attraverso un semplice esame anamnestico e clinico degli arti inferiori.
4. Laddove si ravvisi un problema di insufficienza venosa, completare l’iter con un esame strumentale.
5. Iniziare la terapia. A questo proposito è giusto sottolineare che è importante utilizzare la terapia più appropriata fin dalle prime fasi della patologia, per evitare le complicanze e i rischi.
Nell’ambito della terapia medica, il medico è chiamato a scegliere in base alle indicazioni delle Linee Guida Nazionali e Internazionali e alla Medicina Basata sulle Evidenze (EVB), che oggi indicano in modo chiaro la Frazione Flavonoica Purificata e Micronizzata (FFPM) come la terapia che ha portato i maggiori benefici.
6245
Cura e Terapia – Insufficienza Venosa Cronica
IVC: tutte le cure, dai farmaci alla chirurgia
Per confermare la diagnosi di IVC e per ottenere dettagli anatomici, la tecnica più utilizzata è la valutazione del reflusso venoso con modalità duplex. Per valutare la gravità della malattia spesso si utilizza la pletismografia aerea.
Il trattamento iniziale dell’IVC prevede misure atte a ridurre la sintomatologia e aiutare a prevenire lo sviluppo di complicanze. A questo stadio, in base a quanto riportato dalle Linee Guida per la cura e la prevenzione dell’IVC, le due terapie d’elezione sono:
1. l’uso di farmaci venotropi, come la Frazione Flavonoica Purificata Micronizzata (FFPM), per migliorare il tono venoso, la permeabilità capillare e il drenaggio linfatico
2. l’applicazione alla gamba di una compressione esterna graduata che contrasti le forze idrostatiche dell’ipertensione venosa.
Inoltre, dal momento che l’IVC porta a compromissione dell’integrità cutanea, è importante mantenere l’area colpita ben idratata per ridurre il rischio di abrasioni e infezioni. La comparsa di dermatite da stasi richiede il trattamento con steroidi topici.
Nel caso delle ulcere venose, il controllo della crescita batterica e la cura aggressiva della ferita sono necessari per minimizzare le complicanze infettive. Sono disponibili diversi idrocolloidi e bendaggi schiumosi per controllare il drenaggio dei liquidi dalla ferita e la conseguente macerazione dei tessuti cutanei circostanti. In presenza di un’ulcera infetta, i bendaggi a impregnazione argentica si sono dimostrati efficaci per il controllo dell’infezione e la guarigione dei tessuti.
Infine, è importante l’esercizio fisico graduato, per riabilitare la pompa muscolare del polpaccio e del piede e migliorare i sintomi della malattia.
Indumenti compressivi e terapia farmacologica sono efficaci per il trattamento di tutti gli stadi dell’IVC, ma i pazienti con sintomi gravi generalmente sono affidati a un flebologo: sono quei pazienti, con IVC avanzata e non corretta, a rischio di ulcerazione, di ulcerazione ricorrente e di mancata guarigione delle ulcere venose, con conseguente infezione e linfedema.
Nell’IVC refrattaria alla terapia medica e a quella meno invasiva, la chirurgia dovrebbe essere presa in considerazione a complemento delle calze a compressione graduata per quei pazienti che hanno disagio permanente con disabilità o con ulcere venose che non guariscono nonostante tutti i tentativi medici. Le opzioni invasive e chirurgiche possono anche essere prese in considerazione nei pazienti che non sono in grado di sopportare la terapia compressiva o che presentino vene varicose ricorrenti.
6246
![]()
Il farmaco giusto per curare l’insufficienza venosa
Per la terapia dell’IVC, il farmaco che oggi ha le maggiori evidenze cliniche è la Frazione Flavonoica Purificata e Micronizzata (FFPM) che, grazie a una moderna tecnologia, la micronizzazione, ha un’ottima assorbibilità a livello intestinale e quindi una maggiore efficacia clinica. Ecco perché la FFPM è l’unico farmaco raccomandato da tutte le linee guida, nazionali (Collegio Italiano di Flebologia – CIF) e internazionali (American Venous Forum – AVF), e in tutti gli stadi dell’insufficienza venosa cronica, dai primi sintomi e segni (dolore, pesantezza, gonfiore) agli stadi più gravi (edema, varici, ulcere).
La FFPM è un farmaco flebotropo orale che agisce contemporaneamente su tono venoso, drenaggio linfatico, microcircolo e infiammazione perivasale. I componenti sono per il 90% diosmina e per il 10% flavonoidi espressi come esperidina, che riattivano il tono venoso e linfatico, normalizzano la permeabilità del microcircolo e proteggono la parete venosa dagli effetti deleteri dei radicali liberi. Inoltre si oppongono alla reazione infiammatoria bloccando la liberazione di mediatori flogistici come prostaglandine, istamina e bradichinina.
La FFPM presenta alcune importanti caratteristiche:
-rinforza la tonaca muscolare media della vena: in questo modo la vena, invece di cedere allungandosi e allargandosi, rimane tonica e scompaiono dolore, prurito e pesantezza
-agisce a livello del microcircolo, ossia sui capillari artero-venosi e sul sistema linfatico migliorando la perfusione dei tessuti e il drenaggio linfatico; questo contribuisce a diminuire uno dei segni più evidenti e fastidiosi della malattia venosa: l’edema e cioè caviglie e polpacci gonfi
-è l’unico farmaco ad aver dimostrato di bloccare sul nascere la patologia venosa che è innescata da un processo infiammatorio che colpisce sia la parete delle vene che le valvole a nido di rondine, responsabili del ritorno del sangue verso il cuore
-ha dimostrato che in associazione alla terapia convenzionale (calze e bendaggio) riduce i tempi di guarigione delle ulcere di circa 1 mese, aumenta il numero di ulcere guarite e questo si traduce in un vero e proprio risparmio economico (con l’uso dell’elastocompressione in associazione alla FFPM, il costo della guarigione dell’ulcera è di 1.026 € rispetto a 1.872 € del gruppo con la sola terapia convenzionale, ottenendo quindi un risparmio netto di circa 845 € per ogni ulcera guarita).
6247
![]()
Cos’è la micronizzazione?
La micronizzazione è una tecnica d’avanguardia che permette di ridurre le dimensioni delle particelle di principio attivo di un farmaco in modo da renderlo più solubile e quindi più facilmente assorbibile dall’organismo. In generale, la micronizzazione viene utilizzata per aumentare la biodisponibilità di un farmaco poco solubile.
Per biodisponibilità di un farmaco si intende la frazione della dose somministrata che raggiunge la circolazione sistemica di un organismo vivente e la velocità con cui avviene questo processo.
La biodisponibilità di un farmaco somministrato per via orale dipende innanzi tutto dalla sua capacità di essere assorbito dal tratto digestivo. Per i farmaci poco solubili nei liquidi digestivi, l’assorbimento dipende in primo luogo dalla capacità del farmaco di dissolversi: tanto maggiore è la velocità di dissoluzione, tanto maggiore è la biodisponibilità. Riducendo le dimensioni delle particelle di tali farmaci si migliora la loro velocità di dissoluzione.
La Frazione Flavonoica Purificata è l’unico venotropo micronizzato. Le particelle dei suoi principi attivi sono finemente micronizzate attraverso un processo altamente tecnologico (Broyage a getto d’aria supersonico per 8 ore), nel quale le particelle grazie all’alta velocità e all’energia acquisita, collidono tra di loro riducendo le loro dimensioni da 60 micron a meno di 2 micron.
La riduzione delle dimensioni delle particelle di principio attivo consente di aumentare la superficie di contatto fra il farmaco e la mucosa intestinale, permettendo un assorbimento maggiore e più rapido rispetto ai farmaci non micronizzati.
Uno studio farmacologico condotto per evidenziare gli effetti della micronizzazione sull’assorbimento a livello digestivo della diosmina, ha mostrato che l’assorbimento della diosmina micronizzata è il doppio rispetto a quello dei venotropi non micronizzati.
Un migliore assorbimento si traduce in maggiore efficacia clinica: studi clinici hanno dimostrato maggiore efficacia della FFPM rispetto alla diosmina non micronizzata sia nel paziente con IVC che nel paziente con emorroidi.
6248
![]()
Calze elastiche: quando e a chi servono?
L’uso di dispositivi di compressione gioca un ruolo importante nel contrastare l’IVC, sia in fase preventiva che curativa. Questi strumenti comprendono: calze e indumenti a compressione graduata (suddivisi in varie tipologie come il gambaletto, la calza a mezza coscia, le calze, il monocollant e i collant), compresse di garza e bendaggi elastici.
L’utilizzo di calze a compressione graduata (da 20 a 50mmHg) è ormai prassi comune nel trattamento dell’IVC. Il trattamento con calze che esercitano una compressione pari a 30-40 mmHg provoca un significativo miglioramento del dolore, del gonfiore, della pigmentazione cutanea, della capacità di espletare le normali attività quotidiane e del senso di benessere. Nel caso di ulcere venose, la terapia compressiva è efficace sia per la loro guarigione sia per la prevenzione della loro ricomparsa.
Sono però altrettanto numerose le condizioni che reclamano la contenzione elastica (nel senso non di stringere le gambe, ma di contenerle): dalla ritenzione idrica alla cellulite L’homo viator infatti ha due nemici: il tempo e il calore. Per andare al lavoro, si supera ormai nella maggioranza dei casi un’ora di viaggio, contro il tempo massimo accettabile (45 minuti); in più, viaggi in auto o sui mezzi pubblici, seduti o in piedi, ma comunque fermi, sottopongono le nostre vene a prolungato e diretto contatto con il caldo. Anche per andare in vacanza si supera comunemente il tempo di 4 ore di aereo, con condizioni di statica e pressurizzazione pericolose per le gambe.
Anche gli sportivi possono beneficiare degli effetti della compressione delle calze: recenti ricerche hanno dimostrato che il loro uso comporta ripercussioni positive sull’emodinamica e sul metabolismo muscolare.
Per la realizzazione delle calze elastiche si fa riferimento a principi fisici che analizzano la pressione nell’arto e sulle cosce; in particolare, quando la compressione esercitata alla caviglia supera i 18 mmHg, il tutore è detto terapeutico. Quest’ultimo esercita sull’arto inferiore una compressione definita graduata che è decrescente dal basso verso l’alto, essendo il 100% alla caviglia, il 77% al polpaccio e il 40% alla coscia.
La calza elastica per il trattamento delle patologie flebologiche deve adattarsi alle esigenze del paziente, per evitare che la terapia sia incostante o venga interrotta. Una buona vestibilità, soprattutto per i livelli di compressione più elevati, la facilità a reperire la taglia, il comfort, in particolare nei climi caldi, sono alcune delle caratteristiche che una calza dovrebbe possedere per la riuscita della terapia.
Per aiutare medici e pazienti a scegliere tra calze curative, preventive o di supporto, sono state elaborate da parte del Collegio Italiano di Flebologia delle Linee Guida in terapia compressiva (ultima revisione, 2005).
Tuttavia, in Italia non esiste ancora una normativa né marchi di qualità che possano regolamentare i processi produttivi delle calze elastiche. Inoltre nel nostro Paese la distribuzione di questi prodotti è affidata esclusivamente al canale sanitarie-ortopedie composto da soli 2.000 punti vendita. E non è previsto il rimborso da parte del Servizio Sanitario Nazionale dei tutori, che spesso risultano molto costosi, neppure in caso di patologie gravi. Alcune regioni stanno cercando di ottenere la rimborsabilità per questi dispositivi, ma è necessario stabilire criteri per attestarne la qualità.
6249
Altre cure – Insufficienza Venosa Cronica
Gambe più belle con le erbe
Con il caldo estivo è un classico: gambe e piedi si gonfiano, diventano pesanti e fanno male, oltre ad essere antiestetiche. Ma non tutto è perduto: grazie alle cure naturali, esiste una soluzione per ogni problema.
Se sei predisposta ai disturbi circolatori, probabilmente soffri tutto l’anno di gonfiori e fragilità capillare, e sei particolarmente predisposta allo sviluppo di varici. L’omeopatia è l’ideale per te, perchè ti propone un quartetto di sostanze utili sia per attenuare i disturbi che per prevenirli.
Per gambe gonfie e dolenti c’è Hamamelis virginiana 5CH, dalla spiccata azione vasotonica, mentre le varici possono essere curate efficacemente con l’ippocastano, o Aesculus hippocastanum 5 CH. Le flebiti superficiali, invece, si riducono con Vipera redi 7 CH, mentre per il gonfiore e l’arrossamento tipici delle donne in gravidanza è perfetta la pulsatilla 7 CH. In ognuno di questi casi, sono sufficienti cinque granuli una o due volte al dì per ottenere risultati efficaci e completamente sicuri.
In più, per dare sollievo a gambe e piedi dopo una lunga giornata, si possono applicare degli impacchi freschi di Willow, un fiore di Bach indicato anche in caso di flebiti, oppure massaggiare le estremità con una crema a base di mirtillo.
Un caso diverso è quello delle difficoltà circolatorie che vanno e vengono, cioè che compaiono solo nei momenti di tensione emotiva. L’ideale per questa situazione è la floriterapia. Si parte con un rimedio himalayano, il fiore Down to Earth, che agisce sugli arti inferiori rendendo la circolazione più fluida.
Due gocce del rimedio puro, cinque volte al giorno per una settimana, daranno i primi risultati. Poi si potrà passare a un rimedio più mirato con i fiori australiani: Purple Flag Flower e Damperia per un massaggio drenante che scioglie gli edemi, abbinati ai californiani Sagebrush e Rosemary per agire sulle vene dall’interno.
In caso di varici vere e proprie, si può anche fare ricorso a Bleeding Heart e Willow, che agiscono a livello delle gambe evitando la dispersione delle energie, sia a livello fisico, rafforzando le pareti venose, che a livello emotivo. Le tue gambe ti ringrazieranno.
5491
![]()
Gambe: più vita con la vite!
Sanihelp.it – Il motivo per cui i vendemmiatori francesi non soffrivano quasi mai di disturbi delle vene rimase a lungo un mistero, finché qualcuno non scoprì che durante la vendemmia i vignaioli erano soliti raccogliere le foglie di vite rossa per farne infusi e impasti.
Gli infusi di foglie venivano assunti regolarmente in piccole dosi, mentre gli impasti venivano applicati sulle gambe per alleviarne il gonfiore e il dolore di una giornata di lavoro sui campi.
Fu così che si tramandò il segreto dell’utilizzo di questa preziosa pianta officinale nel trattamento dell’ insufficienza venosa cronica degli arti inferiori.
La vite è un arbusto rampicante, appartenente alla famiglia delle vitaceae, molto sfruttata nell' omeopatia, e nella medicina alternativa in genere, per i suoi principi attivi contenuti soprattutto nelle foglie, ma anche nei tralci, nelle radici, nelle gemme e nella linfa dei rami.
Tali principi sono i flavonoidi, i tartrati, gli acidi organici (tartarico e malico), le pectine, i glucosidi, le vitamine e i sali minerali (bitartrato di potassio e di calcio).
Il colore rosso sangue delle foglie della varietà tinctoria nel periodo autunnale è dovuto alla ricca presenza di tannini antociani, elementi dello stesso tipo della vitamina P, che agiscono contro le sostanze ossidanti che alimentano le pareti vascolari favorendo l’infiammazione e l’edema.
Per l’elevata presenza di tannini le foglie dell'uva hanno una proprietà vasoprotettrice sia a livello delle arteriole che delle venule.
Il microcircolo (soprattutto il retinico) si rafforza grazie alla diminuzione della permeabilità dei vasi e all’aumento della loro resistenza, in conseguenza della stabilizzazione del collagene.
Utilissima dunque la vitis vinifera in tutte le patologie ove sia necessario un miglioramento del circolo arterovenoso:
affezioni venose ( varici, emorroidi, eritrosi, geloni)
malattie cardiache
arteriosclerosi
emorragie retiniche
alterazioni del circolo degli arti inferiori ( flebiti e ulcere)
disturbi della menopausa ( metrorragie)
fragilità capillare ( couperose del viso e piccoli ematomi sulle gambe)
regole dolorose
dissenteria
oliguria
cellulite.
La vite è quindi un’ottima soluzione per le persone costrette a rimanere in piedi per parecchie ore consecutive, in quanto previene i sintomi dei problemi circolatori, quali pesantezza e gonfiore alle gambe, dolori, formicolio e crampi.
E non è tutto.
Oltre alle note proprietà diuretiche, rinfrescanti, dietetiche e antinfiammatorie, le foglie e i viticci raccolti durante l'estate sono ritenuti un ottimo depurativo del sangue, particolarmente adatto ai sofferenti di gotta e artrosi, mentre i fiori e i frutti spesso sono utilizzati per aromatizzare le tisane.
1751
![]()
Camminare in acqua: il toccasana dell’estate
Gambe pesanti? Caviglie gonfie? Piedi arrossati e doloranti? Mal di testa e nervi a fior di pelle? Il rimedio c’è e, seppur antico, è rivitalizzante: riossigenarsi le estremità con una piacevole e rilassante camminata in acqua.
«Del resto l’effetto fisico della passeggiata in acqua, oltre che defaticante e tonico (anche psicologicamente), si ripercuote positivamente anche su chi soffre di patologie angiologiche (ad esempio venose) e laddove il ritorno linfatico è lento se non bloccato spiega il Professor Antonino Di Pietro (Presidente dell’ISPLAD – International-Italian Society of Plastic-Aesthetic and Oncologic Dermatology)».
L’accostamento delle nostre estremità con l’acqua è di immediato conforto. È questa la prima percezione positiva: la liberazione! Le gambe giocano con l’acqua e la circolazione sanguigna ne trae grande conforto.
Sostiene Di Pietro: «L’acqua rende più leggeri e gli eventuali dolori articolari o vascolari tendono a diventare un lontano ricordo. La passeggiata muove l’acqua che, a sua volta, imprime sulle parti colpite un massaggio dolce e ritmato. Una pressione naturale che risale, impercettibilmente, verso il cuore e poi verso la testa fino a regalare un totale relax ai nostri arti e non solo».
«L’esercizio passeggiata in acqua – prosegue Di Pietro – ha indubbi vantaggi nelle arteriopatie periferiche ma anche dove lo stile di vita non è certo da manuale: sedentarietà o al contrario, lunghi tempi passati in stazione eretta, sovrappeso (non importa se fisiologico o legato ad una cattiva alimentazione), cambiamenti fisiologici ormonali. In tutti questi casi, i nostri arti inferiori diventano pesanti e compaiono antiestetici capillari (teleangectasie) con conseguenze assai antipatiche.Tra queste la panniculopatia edemato-fibrosclerotica, altrimenti conosciuta dai più con il nome di cellulite».
«Se camminare – conclude Di Pietro – è la forma migliore di attivazione della pompa venosa, camminare in acqua vuol dire effettuare una compressione esterna assai salutare. Il massaggio costante e dolce, abbinato ad un lento ma maggior lavoro muscolare, in aggiunta ad un minor peso del corpo sulle articolazioni, è il modo ottimale per prendersi cura delle proprie gambe».
6078
La parola agli esperti – Insufficienza Venosa Cronica
Gambe in forma tutto l’anno
Gambe snelle, toniche e leggere sono il sogno di ogni donna. Purtroppo, però, tra vita sedentaria, sovrappeso, tempeste ormonali e problemi ereditari le gambe femminili sono una zona molto delicata: una donna su tre, secondo le statistiche, soffre di gambe pesanti e ritenzione idrica, problemi che con il caldo si acuiscono notevolmente.
La causa dei gonfiori va generalmente ricercata in una cattiva circolazione sanguigna e linfatica.
Negli arti inferiori, infatti, lo scorrimento del sangue è reso più difficile dalla lontananza dal cuore e dalla forza di gravità, e una cattiva igiene comportamentale rischia facilmente di comprometterlo.
I principali fattori di rischio sono il sovrappeso e lo stare in piedi per molte ore, oltre a condizioni particolari quali gravidanza e menopausa. Disperare e rassegnarsi, però, non serve: contro questi disturbi si può intervenire.
Il primo passo, naturalmente, è la prevenzione. A questo proposito la dottoressa Renata Castellano, angiologia dell’Ospedale San Raffaele di Milano, dà qualche consiglio prezioso:
- Tenere il peso sotto controllo e seguire un’alimentazione equilibrata
- Se per lavoro si è costrette in piedi per molte ore, riattivare il flusso venoso alzandosi e abbassandosi spesso sulle punte dei piedi
- Se si ha predisposizione ereditaria ai disturbi circolatori, è consigliabile l'uso regolare della calza elastica
- Dormire e riposare con i piedi sollevati
- Scegliere scarpe con tacco largo di 3-4 cm (no a tacchi alti e scarpe piatte)
- Evitare indumenti troppo stretti
- Evitare fonti di calore dirette sulle gambe, come sole o bagni troppo caldi
- Fare movimento: l’ideale è un’ora al giorno di camminata
- Massaggiare le gambe, con o senza lozioni specifiche, con movimenti verticali dal piede verso la coscia, in modo da riattivare la circolazione
Per contrastare i fastidiosi e antiestetici gonfiori, infine, si può anche agire dall’interno: infusi e tinture madri di alcune erbe, quali ippocastano, mirtillo, vite rossa e amamelide, hanno ottime proprietà antinfiammatorie, lenitive e decongestionanti, e contrastano già ai primi sintomi l’insufficienza venosa e la fragilità capillare.
In caso di 3″>7466″>varici, però, questi accorgimenti non bastano: per evitare il rischio di 3″>3051″>flebiti e 3″>7293″>tromboflebiti occorre ricorrere alla terapia chirurgica.
La tecnica più consolidata è quella dello 3″>6891″>stripping della 3″>6381″>safena, ma esistono anche metodi alternativi basati sull’utilizzo di laser e microincisioni.
Un medico competente e qualche semplice esame di laboratorio come l’ecocolordoppler consentiranno di individuare la terapia più adatta; l’importante è informarsi e non trascurare il problema.
Una donna sana, del resto, deve essere prima di tutto in gamba.
2754
![]()
Laser per eliminare i capillari: una soluzione definitiva?
Le micro-macro telangectasie (ovvero la presenza di capillari di piccole dimensioni, di colore rosso, o di medio-grandi diemensioni, di colore blu-verde) colpiscono di preferenza il sesso femminile (rapporto maschi/femmine 1:4), in soggetti predisposti geneticamente con lieve squilibrio ormonale, per esito di traumi o per fragilità capillare.
I capillari altro non sono che venule dilatate in un contesto dermico solitamente sano e integro, e la loro presenza indica solamente un deficit estetico, assolutamente non funzionale.
Sino a pochi anni orsono si utilizzavano farmaci sclerosanti, ovvero composti chimici che aggrediscono la tonaca intima del vaso, determinandone la chiusura.
Possibili complicanze: tali farmaci sono necrotossici, possono determinare reazione allergica talora fatale, oppure per errore tecnico giungere in piani vascolari più profondi, determinando una grave situazione clinica chiamata flaegmasia caerulea dolens.
Talora il vaso trattato assume colorazione biancastra, non correggibile; il vaso da trattare deve essere di proporzioni più grandi dell'ago più piccolo che si può utilizzare; le sedute sono molteplici (per necessità di iniettare nella stessa zona non più di 5-10 ml di liquido, data la sua tossicità) e costose, con risultati spesso insoddisfacenti.
Tale tecnica oggi è desueta: infatti sono apparse nel mondo della medicina nuove apparecchiature laser, alcune delle quali (laser YAG 1064), molto sofisticate, sono utilizzabili solo da personale medico qualificato ed in Centri Medici con specifiche caratteristiche.
Il laser agisce come fonte di calore secondo bande di assorbimento della luce. È per tale motivo che i capillari verde-blu (di dimensioni maggiori) vengono eliminati al 70% in una sola seduta, mentre i capillari rossi superficiali, per uguaglianza della banda di assorbimento del laser (per l'appunto rosso) e la dimensione (che richiede erogazione di energia inferiore) possono richiedere anche tre-quattro sedute. I risultati sono ottimi, e se la tecnica viene eseguita da uno Specialista in Chirurgia Vascolare/Angiologia i rischi sono praticamente inesistenti.
Se il paziente è stato opportunamente indagato, e la procedura viene eseguita con cognizione di causa, i capillari trattati non si ripresenteranno nel tempo nella zona trattata.
È opportuno che i pazienti che desiderino sottoporsi a trattamento laser siano prima visitati da un Chirurgo Vascolare/Angiologo per valutare la presenza di eventuali controindicazioni ed escludere alcune patologie che ostano la procedura: infatti la presenza di un'insufficienza venosa osta la riuscita di qualsiasi trattamento per i capillari, per iperafflusso venulare che va corretto prima di ogni altra cosa.
Inoltre i pazienti diabetici, coagulopatici, cardiopatici scompensati, in terapia fotosensibilizzante o affetti da malattie autoimmuni, non possono essere sottoposti a trattamento laser.
Il trattamento laser va eseguito su cute non abbronzata (pertanto tendenzialmente non in estate), per il rischio di interferire con la melanina in eccesso e conseguente comparsa di stria biancastra da depigmentazione.
3047
Glossario per Insufficienza Venosa Cronica – Enciclopedia medica Sanihelp.it
Farmaci
– SEGLOR*30CPS 5MG
Tag cloud – Riepilogo dei sintomi frequenti
affaticabilità
dolore agli arti inferiori
astenia
sensazione di bruciore
brufoli
sensazione di caldo e freddo
rottura dei capillari
dolore alla caviglia
lesioni della pelle a livello delle caviglie
disturbi della circolazione
claudicatio
cruralgia
alterazioni del colore della cute
lesioni della cute
macchie puntiformi emorragiche della cute
manifestazioni a carico della cute
sensazione di indurimento della cute
sfogo della cute
debolezza
dilatazione
eczema
edema
ematemesi
esauribilità
formicolii
foruncoli
mancanza delle forze
dolore alla gamba
dolore alle gambe
gonfiore
ingrossamento
ipercromia della cute
iperpigmentazione
lombosciatalgia
parestesie
alterazioni del colore della pelle
lesioni della pelle
macchie puntiformi emorragiche della pelle
manifestazioni a carico della pelle
sensazione di indurimento della pelle
petecchie
sensazione di pizzicore
podagra
porpora
pustole
sensazione di ragnatela sul viso
lesioni alla pelle in regione malleolare
sciatalgia
sciatica
disturbi della sensibilità
sensazione di puntura di spilli
spossatezza
stanchezza
tumefazione
tumidezza
ulcere
ulcere malleolari
varici
vene varicose
sangue nel vomito